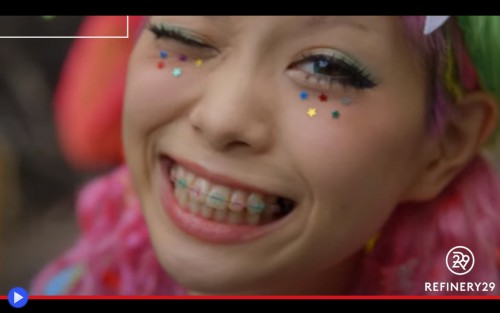L’artigianato proveniente dal Giappone ha sempre avuto questa patina di particolare splendore o meraviglia, che in qualche maniera trascende quello degli altri paesi. Quasi che la migliore opera creativa degli abitanti di quei luoghi avesse preferito esprimersi, attraverso le generazioni, non soltanto attraverso singole ed irripetibili opere o espressioni di un sentire estremamente personale, ma anche per il tramite di tecniche e metodi che, proprio in funzione del loro essere attentamente codificati, potevano permettere di eccellere a chiunque. Naturalmente, dietro un lungo periodo di studio ed apprendistato. Ed è tutto un po’ così, a pensarci: la calligrafia, la produzione di ceramiche, i tessuti riccamente decorati, la tecnica metallurgica per fabbricare la katana… Il sapere del vecchio maestro, che viene eternamente tramandato. E le nuove generazioni che, smartphone, tablet e computer alla mano, nonostante tutto guardano con diffidenza verso qualsivoglia innovazione di quello che capita all’interno del laboratorio; essenzialmente, un tempio. Sacro agli uomini del mondo. Infuso della scienza mistica di chi è venuto prima. Luogo come questa incredibile officina di Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, dove viene messo in pratica un antico metodo, fondamentale per l’economia della regione. State per assistere alla produzione della foglia d’oro, un materiale dalle proprietà straordinarie, noto in Oriente ed Occidente fin dall’Epoca del Bronzo. Ma che probabilmente non aveva mai raggiunto, nella storia, un simile livello di eccellenza!
Di sicuro lo conoscerete. Magari non per nome. Ma chi non ha mai visto le tipiche cornici decorate o determinati arredi sacri nelle chiese del Barocco, o ancora mobili antichi, insegne, vetrine… Si tratta, dopo tutto, del più semplice ed al contempo immediato metodo per dare il colore del metallo giallo alle cose. Quella particolare tonalità e le caratteristiche di rifrazione della luce, che per associazione ispirano un senso estremo di lusso, ricchezza e prestigio, indipendentemente dal contesto di utilizzo. In molti sono coscienti dell’approccio usato per infonderlo, che consiste nell’avvolgere la cosa oggetto del processo dentro innumerevoli fogli splendenti, ciascuno fatto attaccare mediante colla o talvolta, semplice argilla o albume d’uovo. Potreste, tuttavia, non aver mai assistito all’origine di un tale effetto. Che non dovrebbe essere, persino ai nostri tempi, frutto di una semplice vernice o di un processo chimico. Costituendo secondo la tradizione, piuttosto l’applicazione diretta di quello stesso elemento che dovrà suggerire nell’osservatore, attraverso una serie di speciali trattamenti. Proprio così: la foglia in questione non è altro, alla fine, che oro vero, generalmente a 22 carati. Battuto e ribattuto, fino all’ottenimento di una consistenza simile alla carta velina, e poi di nuovo, sempre di più, finché da un singolo lingotto da 1 Kg (appena 11x5x9 mm) si giunga a 7 metri di materiale, per un solo micron di spessore. Tanto leggero che possa sollevarsi con un soffio. A tal punto che la luce lo attraversa con facilità. Così tanto è duttile e malleabile il signore di tutti i metalli, da tempo immemore considerato alla stregua di un’imprescindibile divinità.
Il che non vuol dire che la foglia d’oro sia prodotta sempre nello stesso modo. Ci sono, essenzialmente, due aspetti che connotano la produzione: la miscela di materiali che vengono impiegati nella produzione dei lingotti, e ciò che dovrà separare i pezzi durante la fase chiave della battitura. Entrambi aspetti, sia chiaro, egualmente importanti per determinare la qualità del materiale risultante. A Kanazawa, tradizionalmente, il prodotto è la risultanza dell’unione di tre metalli, ovviamente l’oro (in massima parte, si parla di un buon 90%) argento e rame. Ma il vero ingrediente segreto in mano agli artigiani locali, che fu custodito gelosamente fin dal periodo di Azuchi-Momoyama (1573–1603) è…La carta.