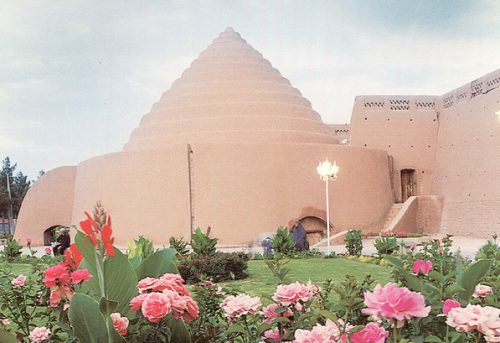Chiunque abbia trascorso più di un paio di mesi su una piattaforma petrolifera con equipaggio ridotto in alto mare, ben conosce i primi sintomi della pazzia. Le giornate che paiono allungarsi all’infinito, mentre il continuo infrangersi delle onde causa il ripetersi di un suono sempre più insistente. L’orizzonte vuoto, del tutto privo di paesaggi se non per lo sbuffo occasionale di qualche balena di passaggio, che pare chiamare colui che osserva, spingerlo a poggiare tutto il peso contro il parapetto. Un braccio in bilico sul vuoto, la mente ormai protesa verso l’Infinito. Finché un giorno, stanchi dopo una lunga giornata d’ispezioni, si torna nell’angusta cabina per dormire. E dopo appena un paio di minuti, con gli occhi già serrati nonostante tutto, si comincia a sognare. Che cosa? Le tenebrose regioni di un grande vuoto, quasi totalmente privo d’illuminazione. Con un senso di gelo attanagliante che penetra le membra, mentre i polmoni avvizziscono e diventano alla stregua di un paio di prugne. Ma il corpo sopravvive, perché hai già le scaglie, e un paio di branchie iniziano a formarsi sui lati del tuo collo. La sagoma distante di un cavo d’ancoraggio rivela la probabile realtà: siamo a molti metri sotto quella casa via da casa, la piattaforma semisommergibile pensata per succhiare il sangue della Terra stessa. Spaparanzato come una stella marina, inizi dunque ad accennare qualche mossa di nuoto. Se non che, la mano destra sente la presenza di qualcosa…Un pezzo… Di stoffa. Morbido e confortevole come la coperta di Linus, quello si avvolge tutto attorno, intrappola le dita. Mentre provi quindi ad agitarti, la stessa cosa avviene a entrame tue gambe. E un velo, fine ma coriaceo, inizia ad appoggiarti sul tuo petto, si avvolge attorno alla testa, spiraleggia fino all’altra spalla. Il quarto pezzo, a quel punto, giunge per coprirti gli occhi. Ma prima che possa compiere il suo scopo, qualcosa di piccolo e veloce fluttua nel campo visivo. Lo sguardo brillante, la bocca aperta, i denti sottili ed affilati. Se non fosse impossibile, sareste pronti a giurarci: quel dannato pesce vi ha sorriso. Poi, tutto diventa pura ed assoluta oscurità.
Come vi fa sentire, tutto questo? Ansiosi, preoccupati? Increduli, infastiditi? In realtà, non dovreste provare nulla di tutto questo. In primo luogo, perché la carnivora Stygiomedusa Gigantea vive tra i 900 ed i 1800 metri di profondità, dove se mai doveste finire senza un solido sommergibile assemblato tutto attorno, assai probabilmente, avreste qualche problema ad impedire che l’enorme pressione comprima i vostri organi e il sistema nervoso, con conseguenze già di per se letali. E poi perché non c’è nulla, in questo placido animale, che possa effettivamente nuocere a un umano, neppure i pungenti nematocisti, le cellule latrici di tossine, che fanno parte del corredo dei suoi simili di superficie. Già, animale. Perché è di questo che si tratta. Benché sembri più una pianta, o ancora, un cumulo di spazzatura tutta attorcigliata attorno a un disco centrale largo fino a un metro, perfettamente simmetrico e dotato di una bocca enorme. Perché dovete sapere che questo essere non ha i tentacoli, come qualsiasi altro appartenente alla sua categoria di invertebrati fluttuanti, bensì quattro braccia boccali, sostanzialmente le sue labbra lunghe fino a 10 metri, con la forma piatta di altrettanti lunghi nastri sinuosi. Che esso impiega, durante le sue peregrinazioni misteriose, per avvolgersi attorno alle prede, impedendogli essenzialmente di fuggire. Affinché la digestione, che inizia grazie ai fluidi trasportati dalle braccia stesse, possa prendere il suo corso necessario alla sopravvivenza. Il tutto colorato di un vermiglio scuro, perché notoriamente la luce rossa non si propaga bene attraverso l’acqua, fornendo una sorta di mimetizzazione ambientale valida a tendere i suoi agguati. Ma sappiate che la Stygiomedusa non fagocita qualsiasi cosa si agiti ed abbia le pinne. In quanto essa si è trovata, oppure ha scelto, la costante ombra di un simpatico compagno: lo hanno osservato capitare gli scienziati, in alcune delle poco più di 100 volte in cui questa creatura è venuta a contatto con gli umani dall’epoca della sua scoperta, circa 120 anni fa. Si tratta di un pesciolino simbiotico appartenente al genus degli Ophidiiformes, noto con il nome comune di brotula marina. Il cui ruolo, nell’intero schema delle cose, non è formalmente chiaro. Benché si ritenga che riesca in qualche modo a sottrarre gli scampoli di cibo dalle lunghe braccia della sua padrona. Mentre la medusa, priva cervello, occhi ed organi, fatta eccezione per la singola gonade centrale, continua lentamente ad avvolgersi attorno a qualunque cosa possa capitargli a tiro. Ora mi direte che non avete mai sentito parlare di una simile mostruosità. Non c’è davvero nulla da meravigliarsi, in tutto ciò…