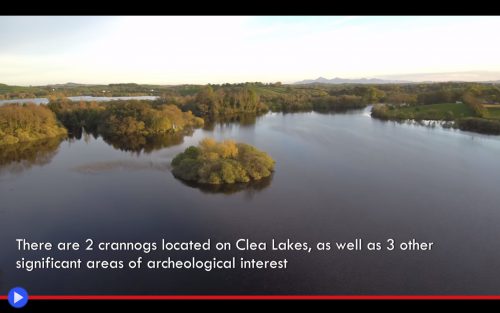La situazione iniziò ad assumere contorni vagamente definiti verso i primi del ‘900: quando l’adozione dei nuovi approcci agricoli e le relative tecnologie di controllo e alterazione del paesaggio portò le genti di Scozia e d’Irlanda a prosciugare il basso fondale di alcuni dei loro laghi nascosti tra il verde di boschi millenari, trovandosi al cospetto dell’innegabile passaggio dei loro antenati. Pezzi di legno chiaramente fabbricati da mani umane, probabilmente facenti parte di un qualche tipo di struttura abitativa, e pezzi di ceramica fabbricati con metodi risalenti (almeno) all’Età del Ferro. Ma soprattutto un accumulo intenzionale di pietre, accuratamente accatastate l’una all’altra, tale da costituire quello che in origine, doveva essere un vero e proprio isolotto posizionato ad emergere tra i flutti, con uno scopo e una funzione difficile da definire. Poco a poco, quindi, gli studiosi iniziarono a compilare un catalogo, delle aree riemerse, quelle sottoposte ad iniziative d’archeologia subacquea e le altre piccole isole, da sempre chiaramente visibili per la popolazione, che tanto lungamente erano state date per scontate ed a cui veniva tradizionalmente attribuito il termine d’associazione incerta crannog (dall’antico termine irlandese crann, con il significato letterale di “piccolo albero”). Ma fu soltanto con l’invenzione, nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera del chimico statunitense Willard Frank Libby, della topica datazione al carbonio 14, che un qualche tipo d’effettiva classificazione poté venire messa in atto per gli oltre 500 siti che gradualmente, stavano continuando ad allungare le liste dei patrimoni culturali preistorici della Gran Bretagna. Il sistema mediante il quale, attraverso la misurazione della quantità d’isotopo radioattivo contenuto in materiali d’origine organica, risultava finalmente possibile desumere l’epoca esatta della dipartita dell’essere, animale o vegetale, di cui aveva costituito originariamente la proprietà. E della seconda tipologia, in quei particolari recessi, era offerta la possibilità di trovarne parecchi, data la particolare composizione chimica e il contenuto d’ossigeno dei loch nella parte settentrionale dell’arcipelago inglese, tali da garantire una capacità di preservare attrezzi e materiale da costruzione in legno assolutamente superiore alla media, garantendo l’apertura di una valida finestra verso l’intento e lo stile di vita degli antichi popoli di tali terre. Così che, entro una decade, la definizione storica della faccenda raggiunse quello che venne considerato per lungo termine l’ultimo chiarimento: i crannog avevano tutti un’età massima di 2500 anni circa, risalendo a un’epoca in cui la pletora delle antiche culture proto-celtiche disgiunte in territorio pan-britannico iniziavano ad assumere un carattere e un’identità culturale comune. Questo, almeno, finché un evento imprevisto non distrusse completamente ogni cognizione precedentemente data per buona: quando i ricercatori all’opera presso l’isolotto artificiale del lago Olabhat di Eilean Dhomhnaill, presso l’isola delle Ebridi Esterne di North Uist non ripescarono quello che poteva soltanto essere, innegabilmente, un recipiente di terracotta risalente all’epoca del Neolitico, ovvero al minimo, 5.000 anni prima dell’attuale data. Una bizzarra, improbabile anomalia? La cosiddetta eccezione che conferma la regola? Ciò venne faticosamente affermato, senza mai veramente crederci, per svariati anni. Ma la situazione sembrerebbe aver assunto, grazie a uno studio pubblicato lo scorso giugno, toni e tinte di un tutt’altro tipo…
terracotta
Da Nuova Delhi, la soluzione sostenibile di un condizionatore di terracotta
Da qualche tempo, i visitatori occasionali della fabbrica Deki Electronics nei dintorni di Noida, zona industriale dell’Uttar Pradesh, non possono fare a meno di provare un attimo di straniamento alla presa visione di quello che potrebbe sembrare a tutti gli effetti l’oggetto fuori luogo di un nido di vespe giganti. Con un centinaio di cellette o tubuli che dir si voglia, in ordine apparentemente casuale, e il chiaro contenuto di altrettante future piccole e fameliche larve. Mentre persino il posizionamento risulta in grado di alimentare un qualche tipo di ragionevole sospetto: proprio innanzi al gruppo elettrogeno funzionante a diesel, dalla parte verso cui le emanazioni di calore da parte di quest’ultimo, precedentemente, agivano come una sorta di supplizio estivo nei confronti di chiunque fosse sufficientemente sfortunato da poter passare di lì. Ondate perfette per favorire l’incubazione delle uova dell’eventuale insetto preistorico, pronto a sollevarsi in volo e completare un quadro che noialtri europei avremmo avuto ottime ragioni per definire “dantesco”. Ma altresì allo stesso tempo, supremamente utili a produrre un altro tipo di reazione, dalle conseguenze decisamente più tangibili nonché immediate: causare l’evaporazione sistematica di una certa quantità d’acqua, fatta risalire ad arte in cima alla struttura grazie all’apposita disposizione di una pompa. Poiché proprio questa, nei fatti, costituisce l’idea alla base dell’ultima invenzione di Monish Siripurapu, artista e architetto fondatore dello studio Ant (formica) di New Delhi, il cui apparente amore per l’intero ordine degli imenotteri sembrerebbe rispecchiarsi nel desiderio di lavorare sempre con la massima dedizione, allo scopo di creare un mondo che risulti definibile, in qualche modo, migliore.
Come nel caso di un gruppo di operai che, grazie al suo Beehive (alveare) da oggi potranno beneficiare di un continuo processo di raffreddamento dell’aria, senza gravare in alcun modo sul costo mensile della bolletta della luce del proprio già oberato datore di lavoro. Troppo facile, troppo bello, in un mondo in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, e nulla può essere prodotto senza un’accurato instradamento delle forze in gioco? Strana concatenazione d’idee. Laddove è proprio a causa delle pur sempre valide leggi della termodinamica, che una simile installazione può riuscire ad assolvere allo scopo per cui è stata messa assieme dal suo creatore. Quando l’aria calda, prodotta in quantità notevole dal gruppo elettrogeno, si scontra con la piccola cascata di Siripurapu traversale ai tubuli di terracotta, per poi proseguire al di là di essi e in direzione della fabbrica surriscaldata. Ma non prima d’aver sperimentato un fondamentale processo di cambiamento.
Nei fatti, lo stesso prodotto dall’interscambio di stato tra i fluidi prodotto, con notevole dispendio d’energia, dai metodi di condizionamento dell’aria maggiormente utilizzati oggigiorno. Senz’altro tipo di spesa, rispetto a quella sottintesa dal bisogno di pompare qualche litro d’acqua ogni ora. Con un approccio alla questione identificato scientificamente col binomio di “refrigerazione evaporativa”….
L’antico Sputnik di terracotta del vino georgiano
“L’origine di tutto” è un concetto per lo più soggettivo, che può configurarsi sulla base di quali siano, in effetti, i requisiti necessari per prendere in considerazione un concetto o un’idea. Per quanto concerne l’esplorazione spaziale, generalmente, si sceglie generalmente il lancio in orbita dello Sputnik 1 dal cosmodromo di Baikonur, satellite sferoidale il cui nome significa in russo “Compagno di viaggio” rimasto nei nostri cieli per 92 giorni a partire dal 4 ottobre del 1957. Nel settore vinicolo invece, altro fondamentale recesso approfondito dall’esplorazione umana, la questione è decisamente più complessa, con diverse nazioni che vorrebbero, ciascuna a suo modo, reclamarne il primato storico. Alcune decadi fa presso l’insediamento di Dangreuli Gora nella valle di Marneuli, tuttavia, una scoperta archeologica sembrerebbe aver fatto molto per schiarirci le idee: attraverso gli strati di terra smossa, riemerse un recipiente del VI secolo a. C. dalle dimensioni simili a una damigiana, al cui interno erano presenti alcuni vinaccioli, ovvero i semi dell’acino d’uva. E per quanto diverse spiegazioni alternative fossero state prese in considerazione, tutti dovettero concordare, dinnanzi all’evidenza, che qualcuno doveva pur averceli messi. Qualcuno che, decine di secoli prima di quanto fosse stato ritenuto possibile in precedenza, stava mettendo in pratica la fermentazione del vitis vinifera, subs. sativa: ovvero in altri termini, si stava apprestando a bere una delle più influenti, importanti e pervasive bevande dell’intera vicenda umana. Ora in epoca più recente, a partire dall’anno 2000, ulteriori scoperte hanno rafforzato il concetto, ciascuna associata a un contenitore di terracotta progressivamente più grande. Il che, del resto, aveva certamente un senso: siamo, dopo tutto, in Georgia, dove il tannino sprigionato dalle doghe delle botti viene considerato deleterio per il gusto di ogni bevanda alcolica, così come l’alternativa moderna del metallo, troppo impersonale e priva di un carattere duraturo. Ragione per cui, attraverso il percorso della civiltà, un’alternativa è stata trovata nella creazione del Qvevri (ქვევრი) un possente vaso dalla capienza media di 800-1.000 litri, con una forma ovoidale e una dimensione vagamente reminiscenti dell’argentea freccetta orbitale russa. Il che significa che volendo, una persona potrebbe facilmente entrarci dentro. Ma anche nel qui presente caso, non è affatto consigliabile, né salutare.
Il Qvevri o Kvevri (c’è una storia divertente in merito alla traslitterazione, secondo cui sarebbe stata preferita la Q soltanto perché “tondeggiante” come l’oggetto associato alla parola) è uno di quei metodi alla base stessa di una particolare cultura, tuttavia rimasto letteralmente ignoti al di fuori del loro territorio di appartenenza. Almeno fino al 2013, quando venne iscritto dall’UNESCO alla lista dei patrimoni intangibili dell’Umanità. Privilegio apparentemente superfluo, per un popolo che li venera come letterale Uovo della Creazione alla base stessa della propria visione gastronomica del mondo, eppure funzionale a un Rinascimento tutt’ora in corso, per una prassi artigianale ormai portata avanti soltanto da poche aziende rimaste operative, con passaggi tramandati attraverso una lunga ed articolata storia familiare. Poiché di certo, produrre una risorsa simile non è semplice, particolarmente quando si sceglie di farlo senza ricorrere a macchine automatiche, sfruttando l’alternativa delle proprie stesse mani, l’unica, per inciso, che possa garantire un’alta considerazione da parte di alcuni dei più rigidi guardiani delle usanze pregresse, i vinai. Con la premessa che ci sono diversi approcci alla costruzione, molti dei quali gelosamente custoditi come fossero dei veri e propri segreti, esiste un consenso sui passi principali necessari per poter accedere alla versione Georgiana del vino: si inizia plasmando l’argilla in una serie di stretti cilindri, fatti asciugare al sole e poi disposti in circolo su strati successivi. Un rispetto preciso delle proporzioni da parte dell’artigiano, a quel punto, dovrebbe donare al costrutto una solidità paragonabile a quella del sistema dell’arco, in cui ciascuna molecola sostiene tutte le altre, nell’agglomerato proficuo di un fluido che era stato, soltanto pochi giorni prima, del tutto Newtoniano. Una volta ottenuta la forma desiderata, grosso modo corrispondente a quella di un limone, i nuovi vasi vengono inseriti all’interno di un forno di cottura grande approssimativamente come un garage, dove verranno mantenuti ad alte temperature per un periodo di almeno tre giorni. Una volta che essi avranno assunto una colorazione tendente all’arancione, indicativa dello stato solido raggiunto, verranno tirati fuori uno alla volta, per passare alla fase successiva della loro preparazione…