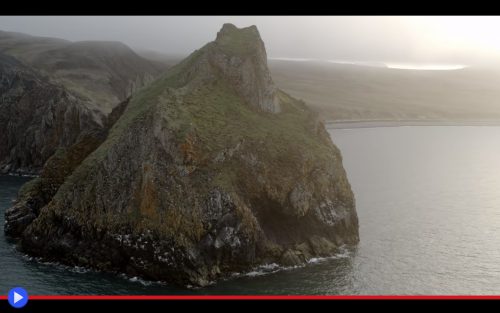Secondo i cultori dell’ipotesi extraterrestre, l’umanità sarebbe mera conseguenza di uno sconosciuto esperimento interstellare. Il frutto derivante dal passaggio delle Ere, di una mera semina sopra un terreno fertile, tra il suolo e l’atmosfera di questo pianeta, al fine di osservare i nostri metodi e comportamenti evolutivi. Davvero improbabile, non sembra anche a voi? In che modo tali esseri a noi superiori, e soprattutto per quale ragione, avrebbero dovuto prendersi la briga di affrontare tutto questo… Ed lo stesso quesito che in ultima analisi, in presenza di una tale inclinazione, avrebbero potuto porsi gli abitanti con le corna di un luogo remoto degli Oceani a noi ragionevolmente conosciuti. Benché un tale sito emerso sia per ovvie ragioni una scoperta piuttosto recente, non antecedente al 1778 quando il tenente Synd della Marina Militare Russa scorse, durante i suoi viaggi nell’Artico, un luogo dove non avrebbe dovuto essenzialmente esisterne alcuno; nel punto mediano tra le coste dell’Alaska e quelle della Siberia orientale, 300 Km ad ovest dell’isola di Nunivak, 370 a sud di St. Lawrence e 425 a nord dell’arcipelago di Pribilof. E a molti giorni di navigazione, dal più vicino luogo abitato dagli umani, che del resto non avrebbero avuto alcuna ragione di recarsi fino a quella sottile striscia lunga 51 Km e con un’elevazione massima di 449 metri. Fatta eccezione per un piccolo avamposto sperimentale della Compagnia russo-americana, che ebbe breve vita a seguito del 1809, e dopo allora fino al cambiamento della situazione in essere, causa l’avanzamento progressivo della tecnologia. Fast-forward verso l’epoca della seconda guerra mondiale: per l’esigenza di disporre di un sistema di radionavigazione del tipo LORAN, con tanto di antenna svettante sopra le distese prive d’alberi di un tale sito distante, un gruppo di 10 addetti dalle forze armate statunitensi sbarcano presso le spiagge di quella che era stata battezzata, già da tempo ormai, l’isola di San Matthew. Soldati scelti non per la loro abilità, addestramento ed elevato morale, bensì per la resilienza necessaria a sopravvivere in totale solitudine presso uno dei confini più remoti della Terra. E accompagnati, come fune di salvataggio, da uno speciale quanto raro tipo di assicurazione: la chiatta contenente un numero di esattamente 29 renne, prelevate direttamente dall’isola di Nunivak.
Ora, il piano non aveva evidenti punti deboli: dopo tutto nonostante l’assenza di alberi, la distante San Matteo/Matthew poteva fare affidamento su un aspetto alquanto verdeggiante nonché rigoglioso, in parte anche dovuto a una straordinaria biodiversità di muschi e licheni, con quasi 150 specie vegetali costantemente intente a replicar se stesse, offrendo una potenziale fonte di cibo per gli erbivori almeno in apparenza sostenibile ad infinitum. Ma non creature onnivore come i loro traghettatori e nuovi proprietari, che avrebbero così potuto per gli anni a venire fare affidamento sulla dispensa quadrupede perfettamente affine al gusto estetico di Babbo Natale. Una spada di Damocle destinata a pendere sulle povere creature ungulate almeno fino al 1944, verso la fine della seconda guerra mondiale, quando la stazione LORAN fu giudicata non più necessaria e quindi abbandonata al suo destino. Esattamente come le renne provenienti dalle terre d’Occidente, di cui in ultima analisi, neppure una era stata uccisa per supplire a una mancanza di derrate. Se questo fosse un semplice racconto sull’interdipendenza delle specie e l’inadeguatezza di quest’ultime a nuove condizioni dell’esistenza, saremmo già giunti al triste epilogo di una vicenda senza conseguenze realmente degne di nota. Ma poiché la vita non è niente, se non adattabile e potentemente intenzionata a ricercare la prosperità futura, nulla a questo punto avrebbe mai potuto più frapporsi tra le renne e il loro ultimo obiettivo, i licheni. Così in assenza dell’unico (potenziale) predatore, l’invadente bipede armato di fucile mitragliatore, esse iniziarono a moltiplicarsi a una velocità inaspettata. Seguono anni di silenzio, in assenza di ragioni per recarsi fin quassù, finché nel 1957, esattamente 13 anni dopo che occhi umani si erano posati per l’ultima volta in questo luogo, il biologo statunitense Dave Klein non sbarcò sulle gelide spiagge assieme al suo assistente Jim Whisenhant. Permettendo ai due, una volta completate le operazioni di sbarco, d’iniziare il processo che li avrebbe portati a contare, nei giorni a venire, una quantità approssimativa di 1.300 simili di Rudolph, l’apripista di Natale. E ciò sarebbe stato, a conti fatti, null’altro che l’inizio del panico a venire…
oceano
La spatola dal becco nero sul confine armato delle due Coree
E chi dovesse perciò dubitare, anche soltanto per un attimo, che la bellezza abbia il potere di salvare il mondo, non dovrà far altro che guardare verso la catena di piccole isolette, poco più che scogli in mezzo al Mar del Giappone, visibili da uno dei confini fortificati più critici del mondo intero. Dove i giganteschi eserciti si guardano da un paio di generazioni, nell’attesa di una dichiarazione di guerra che potrebbe giungere in qualsiasi momento; mentre l’uccello bianco e nero tra i più celebri ed amati di tutta l’Asia viene per trascorrere l’estate, al fine di deporre le uova a gruppi di tre che custodiscono il futuro della sua specie. Ha la dote naturale di pacificare gli animi, del resto, la spatola minore o dalla maschera nera (Platelea Minor) come dimostrato dai numerosi trattati internazionali istituiti nel corso degli anni per proteggere la sua anima migratrice, tra potenze economiche e politiche naturalmente ostili come il Giappone, la Cina continentale, Taiwan ed Hong Kong. Tigri formidabili che pur continuando a girarsi attorno, in un conflitto economico ancor più tangibile e duraturo di quello tra le contrapposte Coree, hanno accettato di buon grado il raggiungimento di una rara comunione d’intenti, pur di garantire la continuativa esistenza di costui. Guadagnandosi le piene congratulazioni da parte di chiunque apprezzi il mondo variopinto e spesso imprevedibile degli animali, contro l’incipiente entropia della biodiversità causata dalla riduzione degli spazi comuni.
C’è ben poco, d’altra parte, che possa dimostrarsi utile ad allontanare la speculazione edilizia e l’eccessivo sfruttamento turistico, quanto vaste distese di campi minati e batterie d’artiglieria puntate vicendevolmente l’una verso l’altra, all’incrocio di una vera e propria tempesta perfetta di una serie di territori lasciati completamente a loro stessi, giusto ciò che serve a specie grandi, magnifiche e rare. Non è comunque difficile inquadrare, in linea di principio, la spatola dalla maschera nera nella sua famiglia dei Threskiornithidae, che include uccelli molto simili assieme agli ibis dal becco ricurvo, benché sussistano una serie di significative differenze sul piano comportamentale. L’affascinante creatura asiatica, imparentata strettamente con la spatola reale australiana (P. regia) dimostra la stessa lunghezza tra i 70 e gli 80 cm per un peso di circa 2 Kg, oltre al caratteristico becco piatto in senso latitudinale, che l’uccello impiega con sapiente maestria nel gesto altamente caratteristico di muovere la testa a destra e sinistra, mentre cerca il suo pasto quotidiano composto di gamberetti, piccoli pesci e molluschi privi di un guscio. Finalità in cui viene aiutato, secondo quanto ha dimostrato la scienza, da alcuni spazi cavi ed opercoli previsti nella struttura scheletrica di tale organo, occupati da appositi organi sensoriali dall’estrema sensibilità al contatto o le vibrazioni. Strumento che non risulta sufficiente, di suo conto, a risparmiare a queste creature il bisogno di trascorrere molte ore intenti nell’attività dispendiosa di procacciarsi il cibo, spesso anche a discapito delle proprie possibilità di futura sopravvivenza. Ed è innegabile a tal proposito, la condizione precaria di una specie tanto affascinante, giunta ad essere rappresentata negli anni ’90 da poco più di 200 esemplari su scala globale, mentre gli sforzi compiuti collettivamente dall’intero consorzio di nazioni dell’Asia Orientale, nel preservare ed ampliare gli spazi naturali occupati durante l’inverno dagli uccelli, ha permesso di migliorare la situazione fino all’attuale classificazione “a rischio” (ma non critico) da parte dell’indice dello IUCN, per un totale accertato di 1.600 spatole. Benché il conteggio delle loro uniche, fondamentali colonie riproduttive, resti off limits agli scienziati, per prevedibili considerazioni di sicurezza nazionale al centro di una delle contese territoriali più delicate dei nostri correnti giorni.
La sanguinosa decisione generazionale della sula
Con un movimento sismico al rallentatore, lui si gira in ogni direzione allo stesso tempo, quindi solleva prima un piede, poi l’altro. Ammirandone la colorazione azzurro intenso, segno di una nutrizione opportunamente salutare e conseguente robusta costituzione, lei squadra con attenzione il resto del suo corpo, inviando l’implicito segnale. Ecco le ali che si aprono, quindi, nel formare un simbolo simile a una “V” che si erge verso il cielo. Le teste si sollevano, i becchi si aprono all’unisono ad emettere un richiamo rauco, eppure significativo. Il seme è stato piantato, inizia una lunga storia d’amore monogamo, destinato a durare fino alla morte di uno dei due. Che sia questo, dunque, il primo capitolo di una tragedia, eternamente uguale a se stessa, che porterà alla sofferenza e il sangue d’innocenti versato tra i detriti che costituiscono quel “dolce” nido…
Per gli esploratori che per primi vennero a contatto con questi uccelli, nei mari tiepidi dell’America Centrale, non fu difficile decidere come chiamarli: bobo o booby che vuol dire “(lo stupido) clown” una creatura grande come un corvo e ad un tal punto incapace di comprendere la gravità e il pericolo a cui stava andando incontro di buon grado, da atterrare tranquillamente sulle navi, con la sua andatura dondolante simile a quella di un pinguino innamorato. Per poi finire subito infilzata negli appositi spiedini, poco prima di essere messa sul fuoco tra la festa e gli schiamazzi di un equipaggio perennemente in cerca di una pietanza saporita e gustosa. Eppure non c’è niente di goffo e impreparato, nello stile di pesca messo in campo da simili esperti volatili affini a i gabbiani, nel momento in cui gli riesce di avvistare un territorio adatto. Per tuffarsi verso il pelo dell’oceano da oltre un centinaio di metri d’altezza, raggiungendo una velocità di fino a 139 Km/h e divorando il pesce ancor prima di riemergere dai flutti e spiccare nuovamente il volo. Una visione impressionante, frutto di una lunga e complicata selezione naturale. Come ci è possibile riuscire a coniugare, dunque, tali aspetti tanto divergenti in una singola famiglia di animali? Che contiene per inciso anche i gannet o Morus, loro parenti prossimi ed originari delle regioni temperate del mondo, affini nei comportamenti e da molti punti di vista esteriore fatta eccezione per le dimensioni ancora maggiori. Il che non basta a liberarli, d’altra parte, della stessa implicita e fondamentale cognizione del concetto di eredità. Ascoltate per comprendere la verità: non c’è una vera malizia nella maggior parte delle scelte compiute, in modo sempre uguale, dagli animali. Al punto che potremmo arrivare a non definirle neppure delle decisioni elettive, sebbene tendano a implicare un’espressione di preferenza portata fino alle più estreme conseguenze qualche centinaia di migliaia, quando non addirittura svariati milioni di anni fa. E tutto ha inizio con lo schiudersi di quel primo, saliente uovo…
L’impervia esistenza di un abominevole granchio delle nevi
Sostanziale prodotto evolutivo del suo ambiente di provenienza, ogni creatura rappresenta il culmine di una lunga sequenza di fattori, portati a combinarsi per l’effetto di una serie di pulsioni: fame, capacità di proteggersi dai predatori e dagli elementi, desiderio di riprodursi. Vi sono tuttavia casistiche, considerate particolarmente irraggiungibili ed estreme, in cui lo stesso tratto fisico può provenire da realtà del tutto differenti, ovvero punti posti dinamicamente all’estremo dell’ideale spettro tra il probabile e l’assurdo. Deambulando con passo pesante tra le nevi del Circolo Polare Artico, l’essere criptico che il mondo ha sempre definito essere “lo yeti” fonda la sua immagine su un grande numero di avvistamenti brevi e accidentali. Tutti concordanti, ad ogni modo, nell’attribuirgli una pelliccia candida e folta sull’intera forma del proprio corpo, essenzialmente non dissimile dall’ideale barba di Babbo Natale.
Che cos’altro avrebbero potuto scegliere di utilizzare, come nome scelto per associazione metaforica, gli scienziati dell’Istituto dell’Acquario di Monterey a bordo della nave di ricerca R/V Atlantis nel marzo del 2006, quando il sottomarino a controllo remoto facente parte dell’equipaggiamento del battello ed inviato a perlustrare la dorsale Antartica situata a largo dell’Isola di Pasqua scorse, per la prima volta nella storia, la biancastra forma di una massa brulicante di creature? Crostacei decapodi non più grandi di 15 cm ciascuno, come apparivano essere oltre ogni ragionevole dubbio. Benché sembrassero possedere alcuni tratti distintivi tali da distinguersi rispetto a qualsivoglia comparabile creatura; vedi per esempio, la folta e spessa peluria in grado di coprire completamente le loro lunghe chele, che agitavano con fare supponente all’indirizzo della sorgente idrotermale sottomarina, fonte di acqua riscaldata fino alla temperatura di un distante mare tropicale, situata al centro esatto della loro surreale aggregazione sulle sabbie situate a ben 2.220 metri di profondità…
Quale altro appellativo, s’intende, oltre a quello del dio polinesiano Kiwa, usato per la definizione scientifica di quello che doveva costituire chiaramente un nuovo gruppo tassonomico, protettore e guardiano dei mari scelto più che altro per la brevità e l’apprezzabile concordanza fonetica col resto del nome latino. E se non può fare a meno di stupirci, d’altra parte, che una creatura significativa come questi artropodi alieni possa essere stata scoperta solamente nel corso del primo decennio del corrente secolo, nonostante la loro occorrenza e distribuzione giudicate in linea di principio significative, ancor più eccezionale potrà risultarvi fare la diretta conoscenza delle svariate specie cognate scoperte da quel giorno fino all’ora ed il momento storico presente, ciascuna depositaria dello stesso, inusitato ramo dell’albero della vita, e in quanto tale ricoperta di una comparabile peluria candida come le vaste distese della neve siberiana. Un tratto certamente degno di approfondimento perché indicativo, come potrete facilmente immaginare, di una specifica funzione ecologica mirata a garantire, oltre il volgere di epoche remote, la continuativa sopravvivenza dell’animale.