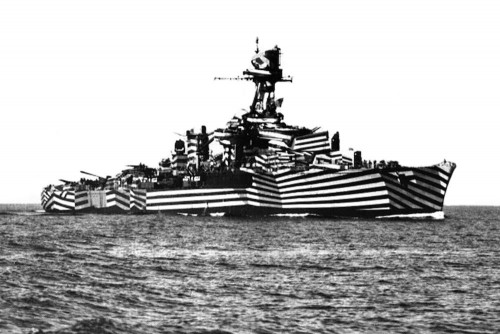C’è una tipica e arcinota rappresentazione degli alieni, che vorrebbe vederli come grossi mostri letteralmente ricoperti d’occhi, per scrutarci meglio da lontano. È una visione strana e innaturale, questa, che ritroviamo negli Shoggoth del mito Lovecraftiano, nei Beholder di Dungeons & Dragons…Il che è piuttosto singolare, visto come nell’intero regno degli esseri viventi potenzialmente dotati del senso della vista, ovvero gli animali, non esista un singolo caso di superflua declinazione di pupilla e cristallino, per ciascun centimetro a disposizione sulla forma fisica di una creatura. Eppure, possibile che ci sia un qualcosa di vero in questo stereotipo spaziale? Forse, quando si considera come un qualcosa di simile appartenga chiaramente al terzo regno, quello minerale. Guardate qui: ce lo sta orgogliosamente mostrando il baffuto Marvin Killgore del Laboratorio Meteoritico del Southwest dell’Arizona, tenendo ben alta sulla testa una sottile lastra, del peso approssimativo di 10 Kg, il cui valore complessivo potrebbe collocarsi intorno a qualche centinaio di migliaia di dollari, se non di più. Tanto è rara la traslucida e preziosa questa pallasite, costituita per il primo 50% di un miscuglio tra ferro e nickel, nella restante parte da un’infinita serie di olivine preziose o veri e propri peridoti, pietre spesso usate in gioielleria. L’uomo, con una notevole dimostrazione di senso del pathos, ha dunque scelto di piazzarsi in controluce, frapponendo nella foto il super-sasso alla più preponderante fonte di luce di un dì privo di nuvole, l’astro solare. Adesso come l’altro ieri, finalmente, questa roccia ultramondana sembra ritornare VIVA e in qualche modo…Attenta. Dunque appare lecita la risultante domanda, del quando, esattamente, fosse “l’altro ieri”…
All’incirca 4,6 miliardi di anni fa, qualche tempo prima di Windows 3.1 e dell’invenzione della Coca-Cola, l’intero Sistema non era altro che un ammasso di materia indistinta, che le fluttuazioni caotiche del vasto nulla avevano portato ad aggregarsi in ciò che la scienza definisce una gigantesca nube molecolare, o proto-nebulosa. Non c’erano ovviamente, asteroidi o pianeti, né la grande massa rossastra di Giove, né lo splendore verdolino del malsano Venere o l’alone rosseggiante dell’antico e polveroso suolo marziano. E neppure, questo resta l’aspetto maggiormente significativo, l’astro del Sole che ci donò la prima, e infine fornirà l’ultima alba. Ovunque e al di sopra di ogni cosa, sussisteva unicamente il Caos. Luci distanti, di stelle o galassie ormai dimenticate, illuminavano la scena dell’ammasso eterno e oscuro, nell’estetica appagante della prototìpica armonia. Finché ad un certo punto, per ragioni largamente ignote, non si verificò l’Evento: un possente urto gravitazionale, come una folata di vento cosmico e spropositato, che giunse ad urtare l’antica amenità, mettendo in moto un infernale meccanismo. La relativa equidistanza degli atomi indistinti, dei metalli e i silicati, dell’acqua e del metano venne compromessa, assieme all’equilibrio della loro separata coesistenza. La teoria maggiormente accreditata, esposta per la prima volta dal filosofo tedesco Immanuel Kant (1724 – 1804) non può che attribuire l’origine di questa interferenza al più catastrofico evento cosmico di proporzioni note, ovvero l’esplosivo collasso stellare di una supernova. Quella non-morte di uno dei nostri attuali astri notturni, che lungi dall’eliminarlo totalmente, lo vede conflagrare in un pauroso scoppio, pari a quello di 2.000 miliardi di miliardi di miliardi di bombe atomiche, seguito dalla compressione inevitabile della (relativamente) poca materia rimanente, in un’iper-pesante nana grigia, o ancora meglio, un misterioso buco nero. Ma poiché il cosmo è un come un enorme flipper tridimensionale, in cui nulla può essere lanciato all’indirizzo di un qualcosa senza influenzare qualche respingente sulla via, ciò che conta non è quel che resta, ma piuttosto tutto ciò che va. E fu proprio il risultante ammasso di materia tormentata, il residuo dell’ipotetica antica stella così defunta, a colpire quello che sarebbe diventato “noi”. Per non parlare poi di “lui” l’augusto meteorite di Fukang.