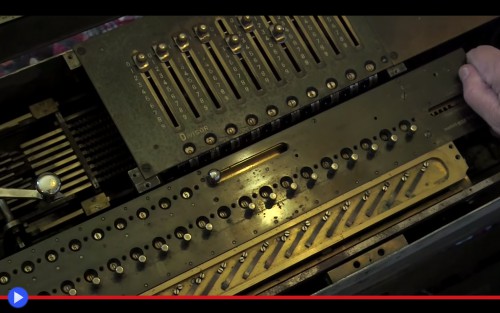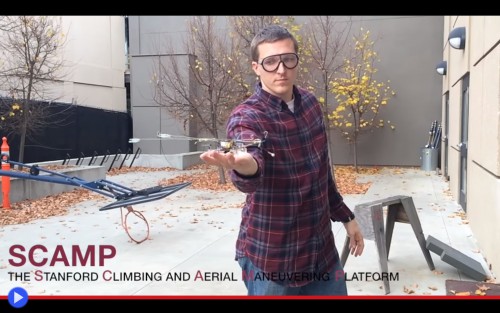Mantenuti dalle macchine all’interno di una realtà parziale, siamo naturalmente diffidenti di quanto ci viene presentato come “nuova tecnologia”. Montaggio ad arte, effetti digitali realizzati al computer, i pannelli monocromatici del chroma key: non sono questi altro che i tre pilastri di un intero edificio di potenziali bugie, dondolante ma solido nel vento delle valide occasioni. Chances di far notizia, generare un clamoroso impatto, cavalcare lo tsunami di una situazione dalle munifiche opportunità di guadagnare. Il che non significa, necessariamente, che quanto quest’azienda, di proprietà del campione di moto d’acqua (Personal Water Craft) Franky Zapata, ci sta mostrando fieramente fin dall’altro giorno sia frutto esclusivo di finzione scenica e una pura faccia tosta. Dopo tutto, stiamo qui parlando dei produttori del popolarissimo Flyboard, un dispositivo che permette di fluttuare sopra l’acqua ad un’altezza di 15 metri, grazie al motore di una PWC collegata ad un lungo tubo ed un ugello a reazione direzionabile. Il tutto controllato da un dispositivo wireless rigorosamente impermeabile. Sistema dall’alto valore d’intrattenimento, che vende nelle sue diverse versioni svariate migliaia di pezzi l’anno, generando un fatturato probabilmente assai considerevole. E perché mai costui dovrebbe rischiare online la sua credibilità latente, mostrando al pubblico un qualcosa di totalmente falso e creato attraverso artifici grafici di vario tipo? Non avrebbe letteralmente, nulla e poi nulla da guadagnarci.
Eppure, qualcosa di strano in questa presentazione di un ipotetico prodotto futuro, c’è. Innanzi tutto, la mancanza d’informazioni fornite al pubblico o inquadrature eccessivamente rivelatorie, scelte comunque giustificabili dal bisogno di non mostrare anticipatamente i propri segreti ai potenziali competitors di settore. Ma soprattutto le tre specifiche prestazionali dichiarate nella descrizione. Con il nuovo Flyboard “Air” (la continuità nei nomi, ci insegna Apple, è un valido strumento dei brand) che sarebbe in grado di raggiungere i 10.000 piedi d’altitudine (3000 metri) fare i 150 Km/h e restare in volo per fino a 10 minuti. Dei quali tre punti, i primi due sono teoricamente anche possibili per quanto concerne il dispositivo stesso, ma difficilmente immaginabili nella configurazione che prevede una persona posta in equilibrio sulla sua sommità, a gambe lievemente divaricate come il cattivo dei fumetti Green Goblin. Ma è proprio il terzo dei valori, in definitiva, ad aver suscitato le maggiori critiche nelle migliaia di commenti postati negli ultimi giorni sul web: secondo la maggior parte delle persone, sarebbe semplicemente impossibile restare in aria tanto a lungo con un dispositivo così piccolo. In effetti, basta considerare la maggior parte dei dispositivi di volo individuale costruiti fino ai tempi più recenti, per trovare un tempo di volo misurabile in semplici secondi piuttosto che minuti, e in definitiva, sicuramente meno estesi. Vediamo, quindi, la questione in maggior dettaglio.
Affinché un simile arnese possa restare in aria per un periodo relativamente prolungato sostenendo il peso di una persona, l’unico metodo di propulsione attualmente probabile è quello di una specifica classe di turbine per aeromodellismo, le P200-RX, che hanno un consumo dichiarato di 0,7 litri al minuto. Ora, il dispositivo di Zapata mostra in una delle ultime inquadrature del video esattamente quattro ugelli nella sua parte inferiore. E questo senza contare le due micro-turbine di colore rosso ai lati che dovrebbe teoricamente impiegare, secondo la teoria più accreditata, come metodo principale di spinta lungo l’asse orizzontale. Stiamo quindi parlando, nella migliore delle ipotesi, di circa 28-30 litri di combustibile (0,7 litri x4 motori x10 minuti). E se nella piattaforma, poco più grande di uno zainetto, ci sono i motori, dovrebbe potrebbe mai trovarsi un simile quibus sine-qua-non? C’è una sola residua possibilità: nello zainetto portato dal pilota, che per l’appunto risulta collegato alla piattaforma da un grosso tubo, il cui impiego a questo punto, sarà più che mai chiaro. Per intenderci, 28 litri corrispondono alla capienza di un forno a microonde di dimensioni medie. Ed è quindi difficile, ma non certamente impossibile, che Zapata disponesse di riserve sufficienti per i tre effettivi minuti del suo primo test. Versioni successive del velivolo potrebbero, teoricamente, vedere l’impiego di borse più grandi… Chi lo sa. Tale aspetto, ad ogni modo, non è insuperabile. Ciò che invece agita il mio senso della credulità, è un altro aspetto del dispositivo in questione: ovvero in quale misterioso modo, colui che si trova a cavalcarlo, possa riuscire a tenersi in equilibrio perfettamente verticale. Specie considerato come, in tale condizione, una semplice svista possa portare ad una morte sicura ed estremamente rapida…