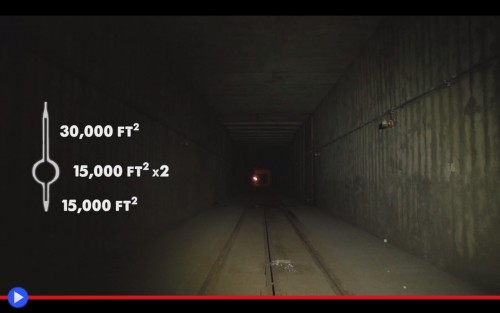Dev’essere la quasi completa assenza di protezioni, esclusa una coppia di piccoli scudi rotondi, a dare un che di gladiatorio alla sequenza. Oppure, forse, il modo in cui i due contestanti si studiano a vicenda, girandosi attorno con fare minaccioso che non trova traduzione in gesti seriamente intenzionati a nuocere, visto lo svolgersi di quello che era assai probabilmente soprattutto uno spettacolo, mirato all’intrattenimento del pubblico pagante o digitale. “Vi state divertendo? Non siete qui per questo?” Sembra quasi di sentire con tono beffardo, prima e/o dopo che i due moderni depositari dell’antica tradizione delle genti Ezhava provenienti dallo stato del Kerala, con fragore clamoroso, inizino a danzare con la morte. O per essere maggiormente specifici con le loro saettanti urumi, queste spade assai particolari che potevano essere nascoste e trasportate ovunque. Pensateci: la qualità maggiore dell’acciaio è la durezza, ma immediatamente dopo quella, nella mente dei suoi primi fabbricanti, spiccava la sua innata flessibilità. Ecco qui un modo per trattare il materiale ferroso estratto dalle viscere del mondo, la cui purezza era tutt’altro che sicura, tramite l’aggiunta di un contenuto carbonifero particolare, in grado di renderlo diverso da ciò che era. Un filo più tagliente, un nucleo interno indistruttibile. Ovvero la certezza, nei propri scontri futuri, di disporre di un attrezzo valido a proteggere la propria vita. Fattore tutt’altro che trascurabile nei tempi precedenti alla moderna civiltà.
Così non era insolito, fin dal primo secolo a.C, che i coloni provenienti dallo Sri Lanka, inviati a pacificare fertili coste meridionali del sub-continente indiano per un ordine ancestrale del re Bhaskara Ravi Varma, si armassero delle progenitrici del riconoscibile talwar o tulwar, la scimitarra ricurva che tanto rassomiglia a quelle della tradizione turca. Ma la più classica delle armi bianche, il nostro simbolo della cavalleria, aveva un problema, soprattutto, nella società dell’India classica divisa in caste: non poteva scomparire sotto agli abiti comuni. Ed era probabilmente assai difficile giustificare la presenza di un tale ingombrante fodero alla vita di chi aveva insufficienti privilegi, sangue nobile o pretesti similari. Pensateci: è sempre stato da un simile presupposto, il bisogno di segretezza, che nacquero e fiorirono alcune delle arti marziali maggiormente amate dai coreografi dei nostri giorni. Non era certamente facile proteggersi da chiunque, inclusi i propri superiori nel consorzio societario, senza mostrarsi già pericolosi al primo sguardo. Le tecniche cinesi di combattimento con il kon, ovvero un semplice lungo bastone. Il nunchaku giapponese, evoluzione di un attrezzo per trebbiare il grano. La pipa, il cappello, il ventaglio da combattimento. E così anche le spade-frusta urumi, parte della tradizione marziale del Kalaripayattu, tanto flessibili da poter facilmente essere avvolte attorno alla vita e poi coperte con la cinta, oppure posizionate in modo tale che spuntasse fuori soltanto l’impugnatura, facilmente sottovalutata come fosse parte di un corto pugnale (nella variante moderna dell’arma, quest’ultima è indistinguibile da quella del tulwar). Mentre bastava un attimo, quando necessario, per srotolare l’inquietante implemento, ed iniziare a mulinarlo con ferocia inusitata. E pensate addirittura questo: nella variante prevista dalla versione usata nell’Agampora, la principale arte marziale dello Sri Lanka, l’urumi poteva presentare anche più di una lama flessibile, trasformandosi di fatto nell’equivalente metallifero del gatto a nove code. Il coraggio necessario per brandire una simile arma, in effetti, doveva essere soltanto di poco inferiore a quello di chi sfidasse il suo proprietario…