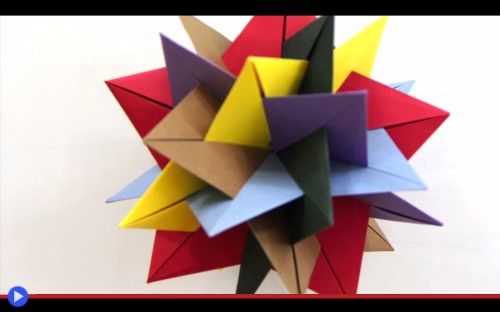Niente cementa lo spirito di corpo di un’armata quanto la lunga ombra di un’insegna: stemmi, vessilli, pregni e forti emblemi sopra un palo. Per questo, quando nell’Era Classica, al suono di tamburi e trombe battagliere, i popoli marciavano oltre i propri confini deputati, c’era sempre almeno un attendente, prossimo al supremo generale, che non portava lancia, spada o mazza ed altre cose similmente contundenti. Ma un qualcosa di ben più terribile e meraviglioso, un utile segno di riconoscimento. Lo strumento psicologico del comandante. Che fosse ben visibile dagli alleati e dai nemici al tempo stesso, affinché i primi ne fossero rincuorati, ed i secondi, quanto meno, intimoriti. Il che dava una seconda dimensione ad ogni tipo di battaglia o di tremendo scontro tra diverse civiltà. Quasi come se sopra la mischia dei soldati, fra tanti fendenti e sangue arroventato, ci fosse una guerra tra figure mitiche di belve o di animali, che si agitavano, girando vorticosamente e si scontravano finché alla fine, senza colpo ferire, l’una prevalesse sopra l’altra, ormai priva del suo portatore, mani umane ed insignificanti. Ogni trionfo era passeggero. Col proseguir dei secoli, alla fine, tutto è destinato a scomparire. Così cadeva nella polvere, dimenticato infine, ogni prezioso simbolo, non importa quanto sacro ed involato sopra i mille campi di battaglia.
Considera l’Europa della tarda Età del Ferro, diciamo intorno al 250 a.C. E pensa a tutti quei popoli, distanti e variegati, che si facevano la guerra tra di loro. Tra cui l’unione politica era impossibile, vista l’ottica del vivere tribale. Eppure ancor distante all’orizzonte, decisamente ben lontana, era la venuta di legioni e centurioni, poi acquedotti, templi di mattoni. Allora, già le genti coltivavano le arti e la filosofia, e si riconoscevano in un corpus di gestualità, usanze e costumi che oggi definiamo con un solo termine, benché si estendesse dalle propaggini occidentali della Spagna fino alla Romania, e su in alto, nelle odierne Inghilterra, Scozia e Irlanda: erano costoro i Celti, molti popoli distinti eppure, con molto in comune tra di loro. Il culto rituale della natura, associato ad un particolare pantheon di divinità. L’abilità in campo metallurgico, nella costruzione di gioielli, armi ed altri manufatti. Nonché un certo modo, primitivo ed entusiastico, di far la guerra, quando necessaria. Il che di certo non gli fu d’aiuto, quando giunse presso il settentrione l’ultimo nemico, Roma invicta, la sua disciplina e tutto quello che portava insieme a se. È facile da ammirare: l’aquila romana, in metallo dorato, con il drappo rosso e il numero della legione. Quanto spesso viene trascurato, invece, il gran cinghiale-mostro simbolo dei celti. Che sulla prima, aveva un gran vantaggio: sapeva emettere un potente verso.