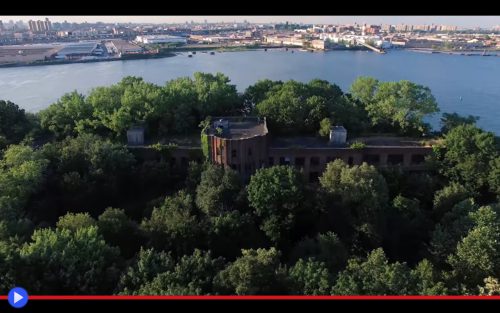Con la guerra alle spalle e una vittoria conseguita grazie allo straordinario potere della tecnologia, gli Stati Uniti sul finire degli anni ’40 erano pieni di fiducia negli eventi dell’immediato, nonché remoto, futuro: la Nazione avrebbe conosciuto la ricchezza di tutti, l’alfabetizzazione perfetta, una rete stradale e dei trasporti del tutto priva di difetti. Tutti avrebbero potuto esprimersi liberamente, alla ricerca di quel principio sacro e universale d’autodeterminazione, sopra il quale governava il senso universale dei popoli finalmente uniti. Pace, cessazione dei bombardamenti e sempiterna sazietà. Una visione del mondo e delle cose che difficilmente può esimersi da modificare a più livelli lo stile di vita della gente, da una maggiore propensione a spendere, alla consapevolezza più che mai giustificata che lasciare un metodo di lavoro imperfetto era possibile, perché il domani avrebbe riservato un metodo diverso per guadagnare. Ed è proprio questo che pensavano anche loro, gli ingegneri e designer automobilistici di più larga fama. Se si spinge lo sguardo indietro fino agli anni ‘2o e ’30, si ha modo di conoscere uno stile motoristico dotato di una bellezza antica, con automobili dalle linee eleganti, ancora simili a carrozze che fossero state magicamente private dei cavalli. Ma dal dopoguerra fino alla prima metà degli anni ’60, soprattutto in Nord America è un tripudio di forme improbabili con pinne, protuberanze, vere e proprie ali sul portabagagli. Con le normative di sicurezza ancora in stato embrionale, ma le catene di montaggio già perfezionate ad un livello comparabile alla tecnica contemporanea, i diversi grandi marchi parevano sfidarsi a chi sapesse creare in mezzo con l’estetica più strana e innovativa, ovvero maggiormente in grado di risultare accattivante quando fotografato dalle riviste di settore, la vera e propria Internet di allora. Ed è questo lo scenario in cui, nel 1948, l’intramontabile mensile Popular Mechanics fece produrre per il cinema questo breve segmento, intitolato in modo pienamente descrittivo: CARS of the FUTURE! Se visto oggi, una vera e propria finestra sullo stile e il gusto estetico di allora, commentato da una magistrale interpretazione della “voce” dei vecchi tempi, quel commentatore spersonalizzato con dozzine di volti e lingue madri in tutto il mondo, che pareva esprimersi a metà tra l’annunciatore di un circo e l’imbonitore delle folle in occasione di colorite fiere di paese. Ma sopratutto con loro, 3 modelli di veicoli dannatamente affascinanti ed al tempo stesso, chiaramente destinati al fallimento di pubblico, visto come non somiglino per niente alle auto che oggi viaggiano sopra l’asfalto.
È un’attenta selezione di quelle che potrebbero definirsi auto utilitaria (oggi la chiameremmo city car) grossa familiare con carlinga in alluminio e fiammante fuoriserie sportiva, ciascuna rappresentante con la massima puntualità la visione delle cose di un particolare progettista, egualmente determinato a lasciare il segno sulla storia futura dell’automobilismo. E tutte egualmente caratterizzate da un’influenza marcatamente aeronautica, perché tutti amavano volare in quegli anni! Con linee morbide, apparentemente pronte ad accompagnare l’abitacolo fin sopra le nubi delle oltremodo lievi circostanze.
Guardare ed apprezzare simili creazioni motoristiche, giudicandole per ciò che sono senza attribuzioni di contesto, è già di per se un’attività meritevole d’attenzione. Perché permette di conoscere il pensiero e l’approccio risolutivo dei tecnocrati all’epoca dei nostri nonni, che ancora lavoravano a stretto contatto con la carta, il righello e la matita, piuttosto che affidarsi all’aiuto procedurale dell’ormai dilagante mezzo informatico, che evita gli errori ma appiattisce il sentimento. Ma è soltanto approfondendo nei dettagli ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo, io credo, che si può giungere a comprendere la vera portata della brusca inversione di marcia sopraggiunta nella storia dell’automobilismo, appena poche decadi dopo quell’arbitrario momento. È un fallimento del tutto imprevisto che riprende, per certi versi, quello dello stesso sogno americano…