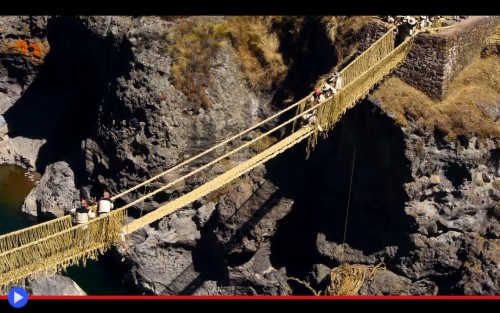La più grande furbizia del topo è stata quella di imparare, con estrema efficacia, la maniera per passare inosservato. Silenziosamente acquattato nelle tane, le intercapedini dei muri, in mezzo alle radici di qualche albero in giardino, attende sempre il suo momento prima di colpire. Rubacchiando il necessario per moltiplicarsi, finché un giorno… Camminando nella notte per andare al bagno della casa di campagna, non odi nel buio quei passetti che rivelano la verità. Ma a quel punto è troppo tardi per accontentarsi di mettere una trappola. O due. Le fondamenta sono una metropoli squittente, che si muove al ritmo di una musica soltanto: masticare, divorare tutto quanto. I danni che i ratti infestanti possono causare alle proprietà degli umani sono quasi inconcepibili: tanto per cominciare, non soltanto mangiano fino a sazietà, ma una parte ancora superiore di vivande le sottraggono, portandole al sicuro nella buca che è la loro casa. Sono diabolicamente abili, nel fare questo. Ike Matthews, un disinfestatore inglese, raccontava nel suo Full Revelations of a Professional Rat-catcher (1898 – di pubblico dominio e disponibile su Project Gutemberg) diversi episodi vissuti durante la sua carriera più che ventennale, tra cui quello di due ratti, ritrovati all’interno di una cantina, con quindici uova di gallina grosse quanto loro, fatte rotolare fino al ciglio delle scale discendenti, poi letteralmente sollevate in qualche modo misterioso e trasportate fino all’intercapedine presente sotto un’asse del pavimento. Il suo libro è un fantastico viaggio nel mondo dell’orrore, con un ricco catalogo d’esperienze, sempre rigorosamente vissute in prima persona dall’autore e quindi comprovate a nostro beneficio, anche a distanza di oltre un secolo di tempo. Alla sua epoca, i roditori regnavano incontrastati, e non era affatto insolito che causassero decessi, non soltanto per l’effetto delle malattie. Uno di loro poteva, ad esempio, facilmente distruggere per il suo istinto di tenere in salute i propri denti un tubo del gas, portando al verificarsi di un pericoloso incendio notturno. O poteva fare lo stesso con quello dell’acqua, allagando abitazioni o locali commerciali. La soluzione? Allora come adesso, tolleranza zero.
Certo, l’uccisione indiscriminata di una genìa d’animali può sembrare crudele, ma è pur vero che queste creature sono tanto prolifiche e resistenti, che probabilmente sopravviveranno alla maggior parte delle altre sul pianeta. Noi inclusi. E sono due, gli strumenti principali usati da questa vera e propria personificazione del Van Helsing letterario: il tradizionale furetto addestrato creato a partire dalla puzzola europea, una vecchia gloria della de-rattizzazione, ed una grande novità tecnica dei suoi tempi, i piccoli “cani da terra” ottenuti dagli incroci con lo scopo specifico di penetrare negli spazi angusti e muoversi agilmente in luoghi inaccessibili, colpendo infine con mascelle rapide e scattanti. Il chien terrier, un concetto originariamente proveniente dalla Francia, doveva avere determinate caratteristiche innate, tra cui una larghezza del torace inferiore ai 35 cm nonostante la muscolatura ben sviluppata, un’indole aggressiva, un senso dell’olfatto molto efficace e l’intelligenza necessaria a comprendere quando fosse il caso di attaccare, e invece quello di tornare a marcia indietro fino al punto d’ingresso della tana. Caratteristica, quest’ultima, particolarmente importante, visto come in origine il terrier fosse stato creato per la caccia ad animali vicini o superiori alla sua stazza, come la marmotta, la volpe o la nutria, l’opossum e il procione negli Stati Uniti, o addirittura il feroce e pericolosissimo tasso. Ma i più grandi successi, simili fedeli cacciatori, fin da subito li conseguirono contro il topo.