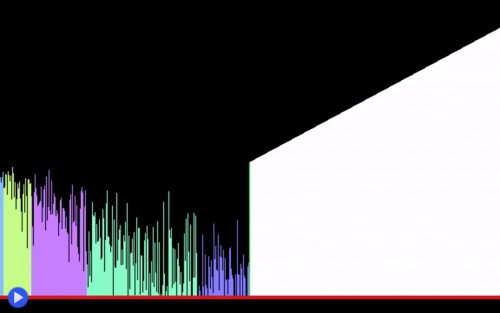Nel quartiere Chiyoda di Tokyo, in prossimità di un triangolo ideale che include gli edifici della Dieta nazionale (l’equivalente del nostro parlamento) la stazione di Nagatachō e lo stesso palazzo dell’Imperatore, la torre svettava maestosa, avveniristica ed ormai, del tutto priva di speranza. Frutto significativo di un periodo d’espansione economica incontrollata, gli anni ’80 della piena bolla economica giapponese, quando i soldi erano pressoché infiniti e chiaramente, i prezzi aumentavano di conseguenza. Soprattutto quelli degli immobili, l’oro preferito degli investitori. Così poteva succedere, improvvisamente, che il prestigioso Kitashirakawa Palace, l’hotel fondato all’interno di una residenza che una cinquantina d’anni prima era stata di Yi Un, principe in esilio di Corea, disponesse di risorse tali, ed un terreno sufficientemente spazioso, da iniziare a trasformarsi in grattacielo. Ma non uno come tutti gli altri, cubico e indefesso: bensì un edificio degno di lasciare il segno, progettato da niente meno che Kenzō Tange, uno dei massimi architetti dell’ultimo secolo trascorso. Il quale, già avviato verso gli ultimi anni della sua lunga carriera (al completamento, ne avrebbe avuti ben 79) appose la sua firma sul progetto di un palazzo certamente insolito, non particolarmente amato dagli amanti della tradizione: 40 piani con una pianta a doppia onda seghettata, con una forma grossomodo a V. Il suo nome: Grand Prince Hotel Akasaka. Edificio costruito rispettando i migliori crismi tecnici dell’epoca, ma che ormai, come capita pressoché ovunque, ci appare inefficiente nel suo isolamento termico, con i soffitti troppo bassi, gli spazi insufficienti per accomodare le infrastrutture tecnologiche e una copertura in alluminio parzialmente rovinata, la cui sostituzione costerebbe cifre niente affatto indifferenti. Ora, se fossimo a New York, Chicago o San Francisco, non è difficile immaginare quello che succederebbe: come per l’Empire State Building, interamente rinnovato più volte, questa vecchia vista cittadina andrebbe preservata, a perenne memento di un’epoca di gloria, ormai trascorsa eppure mai dimenticata. Qualche piccolo sacrificio, da parte dei suoi occupanti quotidiani, sarebbe giustificato con il “fascino” e il “pathos” della sua esistenza. Ma nella terra dell’antico santuario di Ise, il grande tempio shintoista in legno che ogni 20 anni viene fatto a pezzi e poi ricostruito, tra le due alture antistanti nella prefettura di Mie, nulla è fatto per durare più di una, al massimo due generazioni. Iniziò quindi a palesarsi un chiaro sentimento, nella mente degli abitanti del quartiere, dei visitatori di passaggio, dei turisti e delle schiere dei diligenti salaryman con il colletto bianco. Il suo nome: Mono no aware. Il senso [dell’impermanenza] delle cose, fondamento di un’antica strada filosofica dell’Est del mondo. Utile, nel presente caso, a comprendere come quel grosso ingombro cittadino, per quanto riconoscibile e talvolta idealizzato, aveva ormai fatto il suo tempo.
Il che porta a tutta una serie di problemi accessori, tra cui quello principale: come demolire un simile gigante, per di più posto al centro di un quartiere di rappresentanza, circondato da altri palazzi non di molto più piccoli né in alcun modo corazzati? Le moderne tecniche d’implosione, basate sull’uso di esplosivi attentamente calibrati e posti nei punti deboli della struttura, possono ottenere dei risultati davvero encomiabili: tutti hanno visto quella popolare tipologia di video, in cui reliquie dall’imponenza comparabile all’Akasaka tremano d’un tratto, poi iniziano immediatamente a ripiegarsi su se stessi. Una perfetta esecuzione del piano operativo, generalmente, permette di rimuovere qualsiasi colossale monumento all’espansione in verticale, senza compromettere la solidità dei suoi vicini più immediati. Il che non significa, ad ogni modo, che si possa contare su tali metodi in più che una minima percentuale di casi. Perché gli errori, ingegneristici o d’altro tipo, capitano, e prima di procedere con la detonazione occorre chiedere lo sgombero degli edifici circostanti, per lunghe e gravose ore a danno dell’industria. Una strada difficilmente percorribile, in zone topiche come Manhattan o Chiyoda. Ed a questo va anche aggiunto il notevole inquinamento, dovuto alle polveri che si liberano nell’atmosfera. Ma la necessità, da sempre, genera i progressi tecnici del mondo…