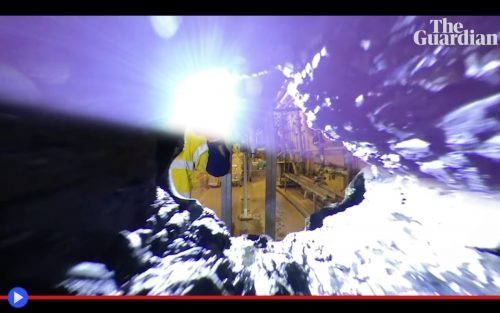Liberatorio è il gesto rapido, fondato su un principio tecnologico, che consiste nella semplice pressione di un pulsante murario. Atto a scatenare, nello spazio definito dalla lucida e biancastra porcellana, la versione attentamente circoscritta di una piccola cascata: acqua che trascina, flusso che cancella, spedizione via lontano di ogni cosa lurida e indesiderata. Inclusa carta igienica e purtroppo qualche volta, soprattutto nei paesi di matrice anglosassone, il problematico strumento della salvietta profumata, la cui scatola riporta rigorosamente il termine flushable: scaricabile nello sciacquone delle casalinghe circostanze. Nessun problema di tipo logistico, per la più importante implementazione urbanistica dell’era tardo-rinascimentale MA. Considerate solo per un attimo, le implicazioni pratiche di un grande ambiente abitativo. Megalopoli di 8, 10, anche 12 milioni di abitanti, ciascuno di essi attento a preservare la purezza del suo preciso territorio abitativo, sfruttando a massimo regime quei condotti sotterranei, orribili e segreti, che la gente chiama sottovoce le “fognature”. Dove tutto è solito procedere nella maniera prefissata, tranne quando, per un caso del destino, smette all’improvviso di farlo. Ed è allora che l’inferno stesso, senza pregiudizi o remore di sorta, riesce a rendersi istantaneamente manifesto su questa Terra. Alla forgia delle anime, per il risveglio di una “cosa” senza volto, forma, o pietà di sorta…
E dire che la genesi di questo essere può presentarsi con un volto familiare ed amico. Hai presente: verde? Alto? Frondoso? Albero dentro l’aiuola? Quale implicazione sconveniente potrebbe mai esserci, nel più accessibile e autosufficiente degli arredi viventi, tanto spesso usato per creare spazi ombrosi, nelle strade di maggior prestigio o percorribilità all’interno di un contesto altrimenti asfaltato. Salvo che la pianta ad alto fusto, per sua implicita natura, possiede entro se stessa il seme di un’irrimediabile vendetta. Così radici serpeggianti, procedendo perpendicolari alla sottile linea ideale che divide il sottosuolo privo di sostanze nutritive dalla superficie, progressivamente giungono fino al grande muro cementizio del passaggio fognario. E con l’insistenza che caratterizza tutti quei processi naturali, gradualmente causano piccole crepe nelle impenetrabili pareti. Nient’altro che insignificanti imperfezioni. Bulbose preminenze che introducono l’irregolarità, laddove tutto scorre (πάντα ῥεῖ) secondo il massimo principio universale dell’Universo. Eppur così come la piccola palla di neve, nasce, cresce e si trasforma in un’enorme valanga, lo stesso avviene per l’ostacolo che impatta il flusso dei liquami, arricchito di una certa quantità di flushables. Che la teoria vorrebbe totalmente biodegradabili. Ma la pratica, sa si… Tanto che ad un certo punto, in quel fatale punto, un vortice si forma e inizia ad autoalimentarsi, rallentando quel che corre ogni minuto verso la distante laguna dell’irraggiungibile salvezza. I fazzolettini si annodano. Ed è allora che le cose, in maniera prevedibile, prendono una piega tanto orribile ed inaspettata.
Ecce fatberg: la parola macedonia (alias portmanteau) formata per la prima volta nel 2008 dai due termini iceberg e fat, ovvero “grasso” sebbene tale semplice definizione riesca largamente a mancare il punto chiave dell’intera faccenda. Ciò perché la prototipica montagna di ghiaccio galleggiante negli oceani, staccatosi dalle isole dei poli più remoti, è un’esistenza vagabonda per definizione, che segue il proprio fato tra le onde inclini a trasportarla via, lontano. Laddove l’esistenza ad essa accomunata, nel profondo delle tenebre maleodoranti, quando nasce non si muove dal suo luogo di origine ed appartenenza. Inamovibile ed eterno, creando l’ostruzione che persiste costituendo una barriera che un poco alla volta, compromette il funzionamento dell’impianto di scarico cittadino. Ponendo le basi di una catastrofe persino troppo orribile da immaginare…
chimica
La ferrovia che taglia un lago rosso e verde come una bandiera
Quel ramo del lago avìto, che volge al vespro, rosa e maleodorante, tra le propaggini di deserto raramente attraversato dai veicoli della moderna civilizzazione; e il ponte che ivi congiunge le distanti rive, dividendo in lembi contrapposti ciò che un giorno era stato unito. Salato, più del mare stesso. Ma non perciò privo di vita, piuttosto che ristoro per gli uccelli che qui sostano, nutrendosi dello strato quasi solido costituito dalle mosche del sale, le ronzanti efidre. Mentre nelle sue profondità, si aggirano miliardi di piccoli gamberi, nati da generazioni successive di uova dormienti. Eppure ciò che maggiormente riesce a caratterizzare nella percezione popolare il bioma del Grande Lago Salato, maggiore dello Utah e ventunesimo nei vasti Stati Uniti, non è questa sua popolazione interconnessa bensì l’effetto che il sostrato basico di essa riesce a indurre nel fondamentale cromatismo della situazione, suddiviso in due metà distinte: intenso e sanguigno da una parte, scolorito e verdeggiante in quella contrapposta, all’altro lato della diga involontaria, ma non per questo meno necessaria alle macchinazioni di coloro che qui vivono, attraverso le generazioni, sin dall’epoca della prima colonia stabilita dai mormoni. Che poi crebbe, in modo esponenziale, fino all’ottenimento dello status di città costiera e capitale dello stato con il nome di Salt Lake City. E si arricchì di un utile viale d’accesso, con la costruzione tra il 1902 e il 1904 di un lungo viadotto ferroviario, la linea di Lucin, costituito da esattamente 19 Km a partire dalla riva di Promontory Point. Un ponte in legno che poggiava sul fondale non troppo profondo, destinato ad essere mantenuto e sostituito per un periodo di quasi 50 anni, quando in considerazione del suo utilizzo piuttosto intenso, con fino a sette treni giornalieri per il trasporto di merci e persone, la compagnia Southern Pacific non decise di affiancargli un diverso tipo di passerella. Ovvero un terrapieno, costruito con gabbioni, detriti e ingombranti pietre, che andasse da una riva all’altra del Grande Lago, suddividendolo essenzialmente in due entità distinte fatta eccezione per un paio di piccole condotte equidistanti dalle contrapposte rive. Dopo tutto, quale poteva essere il problema? Per uno specchio d’acqua per lo più endoreico, privo di fattori d’affluenza fatta eccezione per la pioggia stessa, e già soggetto a significative fluttuazioni della sua estensione attraverso il ciclo prevedibile delle stagioni. Che continuò a procedere, senza immediati cambiamenti apprezzabili dall’uomo.
Finché un giorno, qualcuno non si volse verso levante per notare qualcosa d’insolito e altrettanto inaspettato: “Sto sognando, gente, o le acque hanno cambiato colore?” O per lo meno la metà settentrionale oltre quella muraglia percorribile, dove l’assenza dei fiumiciattoli e torrenti della metà sud, utili a disperdere l’innata salinità di un tale specchio, aveva causato la progressiva modificazione delle condizioni chimiche vigenti. Fino all’eutrofizzazione ad opera dell’alga estremofila rimasta senza concorrenti, quella Dunaliella salina che tanti altri laghi salati, in giro per il mondo, è responsabile di aver tinto di rosa. Ma la scena qui presente, essenzialmente, era del tutto priva di corrispondenze altrove. Perché nel frattempo, all’altra parte dello stretto terrapieno le acque erano rimaste comparativamente incolori, benché tendenti al verde causa la copiosa presenza di Dunaliella viridis e colleghe. Il lago, in altri termini, si era trasformato nel vessillo di un’alta bandiera ed a nessuno sembrava importare particolarmente, apprezzandone anzi gli ottimi presupposti turistici sugli abitanti degli stati vicini. Almeno finché verso il principio degli anni ’80, lo squilibrio tra i livelli delle due metà non causò una serie d’inondazioni durante un periodo di piogge particolarmente intense, con conseguente danneggiamento delle attività industriali e agricole nate nel frattempo all’altro lato della città di oltre 200.000 abitanti. Essendo stati colpiti dove fa più male (il flusso ristorativo dei denari) venne deciso in tutta fretta, a quel punto, d’intervenire!
Gli insidiosi laghi dell’Australia ricoperta di sale
Quando si considerano gli aspetti orografici del territorio, non si è soliti prendere in considerazione l’entità della minaccia custodita nel particolare rapporto tra gli elementi sotterranei e l’esistente falda acquifera, normalmente raggiungibile soltanto tramite un’approfondita trivellazione, subito seguente alla prima costituzione dell’insediamento umano. E così sarebbe andata, per un tempo ragionevolmente lungo, anche nel più nuovo dei continenti, inteso come terra coloniale dell’impero inglese, presto destinata a trasformarsi nella nazione australiana. La questione si sarebbe palesata, quindi, un po’ alla volta, per la progressiva rimozione di uno stato in essere delle pre-esistenti cose. Ed alberi, cespugli, siepi dalle radici naturalmente profonde. Tali da mantenere un più proficuo tipo d’equilibrio…
Di laghi come quelli che compongono il gruppo effimero che persiste, ormai da tempo, qualche chilometro a sud-est della città di Perth nello stato di WA (Western A.) ve ne sono parecchi disseminati nell’intera regione ed anche oltre, propensi a comparire a seguito di piogge intense e quindi rimanere in essere per tempi sufficientemente lunghi da guadagnarsi un nome. Ma non abbastanza, nella maggior parte dei casi, per comparire sulle guide turistiche internazionali. E così questo particolare cluster, fotografato assai probabilmente via drone e pubblicato periodicamente su diversi social network, finisce per diventare la simbolica costellazione di un’antica serie di cause ed effetti, che con il procedere dei giorni non potrà fare altro che raggiungere le sue più estreme conseguenze finali. Milyunup, Racecourse, Munrillup, Balicup (e molti altri privi di un appellativo) compaiono per questo in asse l’uno rispetto all’altro, come residui molto successivi dell’antico corso di un fiume ormai scomparso, e di una serie straordinariamente varia di tonalità distinte: rosso, arancione, azzurro, persino viola. Le quali tendono a scomparire e ricomparire in base alle condizioni ambientali, qualche volta scambiandosi di posto. Perché conche come queste, a meno di 100 Km dalla costa, sono soliti funzionare come punti di raccolta dell’aria salmastra proveniente dal Pacifico, entro cui nei secoli dei secoli riesce a concentrarsi una quantità di sodio sufficiente a generare una vero e proprio ecosistema. Di alghe alofitiche come la Dunaliella salina, la Dangeardinella saltitrix e molti altri organismi pirrofiti, inclini a pubblicizzare la propria presenza tingendo in modo variegato le accoglienti acque d’appartenenza. E se questo fosse il nesso dell’intera questione, nonché il suo solo effetto, non ci sarebbe poi granché di cui preoccuparsi. Ma l’equilibrio salino del suolo australiano è da sempre una problematica sotto stringente sorveglianza, in modo particolare da quando, verso l’inizio del Novecento, una grande quantità di terreni agricoli iniziarono a diventare progressivamente meno fertili. Prima di essere riconquistati, progressivamente, dall’estendersi dei vasti deserti dell’entroterra. Con una motivazione che potremmo ricercare, ed individuare, proprio nel processo sito alla base della loro stessa implementazione nelle decadi antecedenti. Poiché l’uomo, con intento prevalentemente agricolo, aveva provveduto al disboscamento previa definizione dei terreni destinati alla produzione del suo sostentamento. E sempre l’uomo, continuando a fare quel che gli riesce meglio, ha continuato a costruire tutto attorno vasti insediamenti e veri e propri agglomerati urbani. E per quale ragione in ultima analisi, tutto questo avrebbe mai dovuto essere del tutto privo di conseguenze?
L’inaccessibile lago corrosivo nell’Africa dei fenicotteri rosa
Lo spirito della sopravvivenza ecologica è la risultanza di una serie di parametri ambientali, posti in relazione con le caratteristiche biologiche degli animali, da cui derivano percentuali di sopravvivenza rilevanti per determinare l’andamento dell’evoluzione. Immaginate ora di essere in possesso, come specie, di una serie di caratteristiche capaci d’influenzare l’inerente correlazione di tali parametri, determinando possibilità d’accesso a luoghi totalmente inaccessibili alla maggior parte dei più pericolosi nemici o concorrenti. Luoghi come un antico e vasto bacino idrico, all’ombra di un vulcano, tanto alcalino e salato per il contenuto delle precipitazioni in essere da risultare corrosivo per la pelle, gli occhi ed ogni altra parte anatomica di ogni possibile visitatore. Fatta eccezione per gli uccelli che al di sotto di quei flutti pescano, col becco nero e ricurvo, generose quantità di alghe cianobatteriche dal vermiglio pigmento. Così come rossa è l’acqua del lago Natron in Tasmania, che ne è colmo fino ai limiti, e rosa i suo principali abitanti, tutti rigorosamente occasionali, che qui giungono regolarmente durante la stagione secca per deporre il singolo grande uovo bianco, sopra le isole sicure degli agglomerati d’evaporite salina. Quale miglior modo di assicurarne la schiusa d’altra parte, nelle possibilità a disposizione del tipico fenicottero minore (Phoeniconaias m.) che un fossato invalicabile per iene, licaoni ed altri carnivori di terra, ove coltivare, in vasti assembramenti, la realizzazione della propria discendenza futura. E non è un incidente del destino se alla stima più probabile, è stato determinato come circa il 75% dei nuovi nati di questa specie non particolarmente comune, allo stato attuale, possano far risalire i propri natali a questo particolare paesaggio alieno, unico persino nel variegato e vastissimo paesaggio africano.
Una possibilità massimizzata come dicevamo, piuttosto che inficiata, dalla limitata biodiversità di questo ambiente, dove l’assenza quasi totale di pesci fatta eccezione per tre appartenenti al genere Tilapia ha favorito la proliferazione nutritiva dei batteri estremofili, tra cui il prevalente Arthrospira platensis noto all’industria dei cosmetici col nome non del tutto corretto di alga spirulina, trattandosi di un procariota del tutto privo di struttura fogliaria. Per cui l’alta quantità della sostanza corrosiva che da il nome al lago, quel natron composto in parti equivalenti di carbonato e bicarbonato di sodio, costituisce una fonte d’energia potenziale tutt’altro che indifferente, capace di permetterne la proliferazione a oltranza, ulteriormente favorita dalla posizione geograficamente remota di questo luogo, distante (per ora) da ogni possibile fonte d’inquinamento o alterazione dei delicati equilibri chimici da parte della mano umana. Mentre con il progressivo aumento delle temperature e conseguente ridursi del livello delle acque, soprattutto durante i mesi estivi, la sopravvivenza dei fenicotteri viene garantita in questo luogo più che in altri, data l’emersione di un maggior numero di siti adatti a nidificare e una concentrazione superiore del brodo vivente che costituisce la parte maggiore della propria dieta. Un idillio il cui futuro, nelle decadi a venire, appare ormai tutt’altro che sicuro, ahimé…