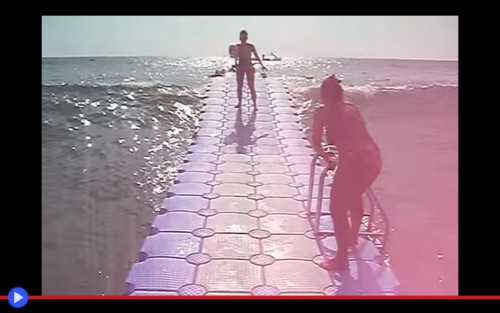Strisciando delicatamente sulla foglia, questo bruco non ha i piedi. Si affida piuttosto ad un sistema di locomozione basato su una serie di contrazioni ritmiche del suo addome, naturalmente in grado di aderire ad ogni superficie. Per agevolare il compito di spingersi innanzi, l’insetto secerne addirittura un fine muco scivoloso, non dissimile da quello di una lumaca, alla quale viene spesso paragonato. Ma a colpire l’occhio dello spettatore non è tanto questa sua caratteristica, quanto l’aspetto generale della piccola creatura: semi-trasparente e bitorzoluta, con la capacità di riflettere la luce in molte direzioni, come la categoria di oggetti da cui prende il suo nome comune. Bruco gioiello, usano chiamarlo. E osservando di sfuggita il qui presente video, credo vi sarà facile comprenderne il motivo. Ma non sarebbe a questo punto lecito chiedersi da dove viene costui…Verso quale lido, in effetti, se ne va.
Tutti i lepidotteri sono monofiletici, ovvero discendono da un antenato comune. Ed è per questo che l’umana distinzione tra farfalla e falena, benché netta e imprescindibile nel senso comune, deriva in realtà da una serie di osservazioni coincidenti tra di loro solo in parte, che per di più sono spesso tutt’altro che assolute e qualche volta, persino, soggettive. Punto primo: l’ora del giorno. Tutte le farfalle amano volarsene in giro durante la mattina e il pomeriggio, mentre le loro controparti preferiscono la luce tenue della Luna? Non proprio, esistono eccezioni. Punto secondo: la struttura delle ali. La tipica falena presenta un filamento che accoppia le due ali di ciascun lato (in totale, tutti gli appartenenti all’ordine ne hanno quattro) per assisterle nel battito sincronizzato. Molte farfalle invece no. Salvo eccezioni. Poi, la metamorfosi: la falena forma un bozzolo di seta, ricoprendosi con tale sostanza appiccicosa per proteggersi nel corso del periodo più delicato della propria vita. La farfalla, guarda caso, la impiega solamente per assicurarsi ad una foglia o ramo, poco prima di diventare crisalide, una situazione statica in cui soltanto una dura e spessa pelle dovrà frapporsi tra gli agenti atmosferici ed il brodo delle cellule, che andando incontro alla liquefazione si riformeranno nella sua versione fisica capace grado di volare. Ma di nuovo, ci sono falene che diventano crisalidi, e farfalle, invece, che fanno l’opposto. Lo stesso vale per le antenne ed il resto del corpo, ali escluse: le falene sono spesse e le farfalle sottili, ma non sempre.
Il che ci lascia un singolo tratto distintivo che possa dirsi non soggetto a contraddizione, per il semplice fatto che rientra nel reame dell’estetica, in cui la mente comanda ed è possibile scegliere di aver ragione. Se soltanto lo desideriamo, per così dire, sufficientemente a fondo: le farfalle, da un punto di vista meramente tradizionale, ci appaiono come più “belle”. L’insieme delle caratteristiche citate, tra cui soprattutto la predilezione a spiccare il volo durante il giorno, puntando su un tipo di camuffamento che confonda la propria sagoma tra i fiori e la vegetazione, porta le farfalle ad avere una livrea straordinariamente variopinta e geometricamente imprevedibile, mentre la maggior parte delle loro cugine che escono di sera, per passare inosservate agli uccelli, devono limitarsi a una livrea molto scura e/o uniforme. Sia chiaro che un simile dato, come del resto tutti i precedenti citati, non è per niente assoluto. Benché si presti ad utili generalizzazioni. Ed un’osservazione: se le sfarfallanti creature della notte sono davvero costrette ad essere marroni, nere e poco altro, che dire allora della loro forma larvale, quel duraturo stadio della vita in cui esistono in forma di striscianti folìvori e devono affrontare un’ampia serie di predatori dalle propensioni totalmente differenti, quali formiche, ragni ed altri agili camminatori… I cui occhi difficilmente potrebbero tralasciare ciò che giace semi-immobile di fronte a loro. Siamo dunque sicuri che non sarebbe meglio, per loro, adottare una diversa strategia di difesa? Ebbene, la risposta delle Dalceridae, una famiglia tutt’altro che numerosa di falene (appena 84 specie all’attivo) appartenenti all’ecozona neartica (America settentrionale e centrale) sembrerebbe configurarsi come un roboante, catartico ed altisonante: “Hell Yeah!”