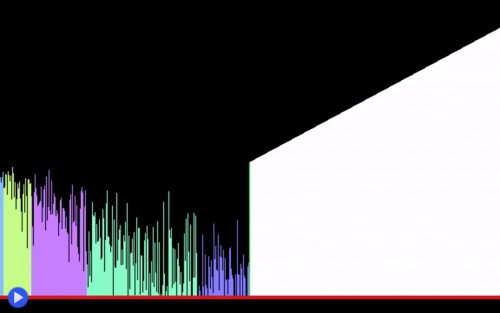Le trovi sulla spiaggia, quando sei davvero fortunato, pallidi residui della vita che era stata. Tonde e traforate, qualche volta, sempre con un fiore disegnato a cinque petali, più o meno a rilievo e al centro oppure no. Gli antichi credevano che fosse la valuta dei tritoni stessi di Nettuno, usata presumibilmente per comprare birra tra i locali alla barriera corallina. Di conchiglie assurte al ruolo di monete, del resto, la storia ne fu piena. Ma se resti concentrato, continuando a cercarle tutto attorno, alla fine ne potresti vedere addirittura una che…È ancora in grado di espletare. Strisciando, camminando, lievemente alla ricerca di piccoli cobepodi, alghe diatomee, larve di molluschi a altri detriti vari. Potrà non sembrarlo ma, questo dischetto deambulante dal diametro di 7 cm e mezzo, è in effetti uno spietato e inesorabile predatore. Che si sposta alla vertiginosa velocità di un metro l’ora di velocità, almeno quando ha particolarmente fretta di trovarsi in qualche luogo non esattamente definito. L’origine della metafora alla base del suo nome non è veramente, dopo tutto, così difficile da rintracciare: la maggior parte dei sand dollars, come vengono definiti in tutto il continente americano (potere della valuta forte) sono piatti e tondi, con proporzioni del tutto simili a quelle di una vecchia moneta d’argento. Il che non significa, ad ogni modo, che siano facili da notare. Questo perché dopo qualche millennio di evoluzione, a partire dai cassiduloidi del periodo Giurassico, hanno appreso i due segreti per sfuggire ai loro predatori dell’età adulta, soprattutto gabbiani, ma anche il pesce piatto Platichthys stellatus o la grande stella marina rosa, Pisaster brevispinus; il primo è muoversi davvero molto, molto poco, il secondo è non esporsi mai alla luce del sole. Persino quando, come capita praticamente tutti i giorni, la marea si ritira dalle acque basse in cui amano abitare, benché siano in grado di costituire colonie a profondità di fino a 90 metri. Perché allora, scoperti e vulnerabili, possono morire anche soltanto seccandosi, ghermiti da quei raggi che per noi sono la vita. Iniziano quindi, quasi subito, a scavare. Ma come, potrebbe chiedersi qualcuno, può infilarsi sotto la sabbia, un animale che è sostanzialmente un piccolo dischetto semovente, spinto innanzi da una forza niente affatto chiara? Il segreto sarà netto ai vostri occhi, se soltanto lo raccoglierete, per girarlo ed osservare la sua parte sottostante.
L’ordine dei Clypeasteroida, che comprende specie diffuse in America, Sud Africa ed Australia, appartiene al phylum degli echinodermi, lo stesso dei cetrioli di mare, i crinoidi, le stelle marine e soprattutto loro, i ricci di mare, con cui ha in comune la struttura fondamentale del carapace ed il sistema di locomozione, formato da innumerevoli sottili preminenze, ma non spinose, in questo caso, bensì ricoperte a loro volta da un migliaio di sottili zampe tubolari, dette cilia. Ed è questa, sostanzialmente, l’unica interfaccia della creaturina con il mondo, che la impiega per ogni sorta di mansione, inclusa quella di guidare sapientemente le piccole prede d’occasione verso il foro al centro del suo disco, che costituisce, neanche a dirlo, l’organo fondamentale della bocca. Può in effetti capitare di vederne un’intera colonia, nei periodi del giorno in cui sono sommersi, che si è disposta nella corrente in modo obliquo e trasversale, dozzine o centinaia di alettoni da tunnel del vento, posti a catturare e poi fagocitare tutti quei micro-organismi che, per loro sfortuna, si trovavano a passare di lì. E pensare che anche loro erano stati, nell’età giovanile, esattamente lo stesso tipo di creatura! Un dollaro di mare, infatti, nasce come larva della tipologia nekton, ossia in grado di nuotare in tre dimensioni, che attraversa vari stadi di metamorfosi, fino al formarsi del suo scheletro calcareo, abbastanza pesante da legarlo per il resto della vita al suolo e trasformandolo in benthos, creatura dei fondali. Ciò detto, persino in quello stato il Clypeasteroida medio è tutt’altro che indifeso, e può ricorrere ad un trucco estremamente funzionale…