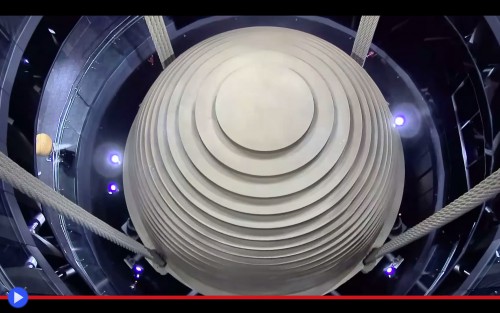Nel corso dell’anno, la parte meridionale dell’Oman è uno dei luoghi più secchi e inospitali del pianeta, con temperature che raggiungono anche i 50 gradi e piogge estremamente rare, concentrate in genere nel solo mese di gennaio. Sulle coste dell’Oceano Indiano, tuttavia, a meridione dell’istmo che dà l’accesso alle acque economicamente significative del vasto golfo d’Arabia, esiste un luogo assai particolare, in cui una commistione fortunata di fattori genera una trasformazione climatica semplicemente senza uguali al mondo. Nel giro di un paio di giorni al massimo, la temperatura scende ad appena 25 gradi sopra lo zero. Piogge incessanti battono le pendici dei colli e le montagne circostanti, causando lo straripamento di fiumiciattoli e torrenti d’altura. In poco tempo, si formano cascate, mentre la foschia insistente copre le campagne di una cappa impenetrabile, in grado di rendere un leopardo del tutto invisibile da una distanza di 8 metri. I cammelli accorrono ad abbeverarsi in massa presso le wadi (valli) permeabili ed improvvisamente inondate, del tutto simili a laghi spuntati dal nulla. Ed è a quel punto che gli arbusti ed i cespugli della regione, del tutto scarni per la maggior parte del tempo, iniziano improvvisamente a dare scena di un rigoglio eccezionale, mentre l’erba cresce, direttamente dal suolo sabbioso delle zone quasi desertificate. Qualcuno, in via rigorosamente informale, ha descritto tale transizione come un magico passaggio dal Sahara all’Irlanda.
Ma qui siamo, in effetti, nella terra di Salalah, città portuale, e del suo miracoloso Khareef, appellativo locale (derivante dalla parola che in altri contesti vuole dire autunno) per riferirsi al fenomeno annuale dell’inesorabile monsone. Succede da circa 15-20 milioni di anni, ovvero già da molto prima che gli umani avessero il privilegio di goderne i benefici: con l’incedere delle stagioni, al sopraggiungere delle temperature più elevate all’equatore, l’aria si riscalda in modo differente in base alla capacità termica di ciò che ha sotto, ovvero terra ferma, oppure acqua salata. Nel secondo caso, infatti, per l’effetto termico della convezione e della conduzione, gli strati freddi al di sotto dei 50 metri di profondità non permettono alla superficie di scaldarsi oltre un certo limite, mentre la sabbia, il suolo e le rocce, nel frattempo diventano letteralmente incandescenti. Ma poiché l’aria calda tende a salire, sulle coste si genera un fronte di bassa pressione, sostanzialmente un vuoto pronto ad essere riempito. E la natura, da che ci hanno lasciato i dinosauri, non tollera mancanze d’equilibrio. Così avviene che questa ingente massa d’aria relativamente fredda, ed estremamente umida, avanzi poderosamente, nella prima parte di un ciclo che la porterà, nel giro di qualche mese, fino all’entroterra più elevato, per poi tornare nuovamente al punto di partenza. Gli effetti sono, come da prerogativa dell’ambito relativo al clima, estremamente variabili. In determinati luoghi affetti da simili circostanze, tutto ciò che le popolazioni locali percepiscono è un leggero calo di temperatura, con precipitazioni più intense nei mesi che vanno da giugno a settembre. In altri àmbiti geografici, invece, l’effetto del monsone è un letterale punto di svolta ecologico, che porta al risveglio d’innumerevoli specie di piante ed animali che, come colti da un’ispirazione improvvisa, senza bisogno di consultare il calendario, lo usano a supporto nei loro periodi di maggiore attività. Dire che le zone circostanti la ridente città di Salalah, tra i maggior porti del Medio Oriente, appartengano alla seconda categoria, sarebbe quasi sottovalutarle. Perché soltanto qui succede che una vera e propria catena montuosa costiera, principale caratteristica territoriale del governatorato di Dhofar, agisca da barriera, permettendo al fronte d’aria umida di soggiacere per un tempo medio-lungo, portando i benefici prolungati dei suoi effetti alla regione. Si può affermare, in effetti, che il Khareef sia diventato negli anni semplicemente necessario alla sopravvivenza di molte comunità locali, che in sua assenza non avrebbero modo di procurarsi l’acqua necessaria per l’irrigazione, vista l’assenza di fonti rinnovabili a loro disposizione. Non per niente, l’arrivo della stagione è oggetto di celebrazioni e feste popolari, con il centro abitato che si riempie di spettacoli e fiere, mentre braceri profumati tentano d’indurre i molti visitatori all’acquisto dell’incenso locale, antichissima esportazione di queste terre, fin dai tempi biblici e dell’antico impero dei faraoni.