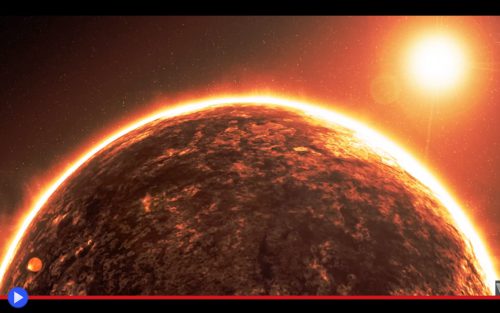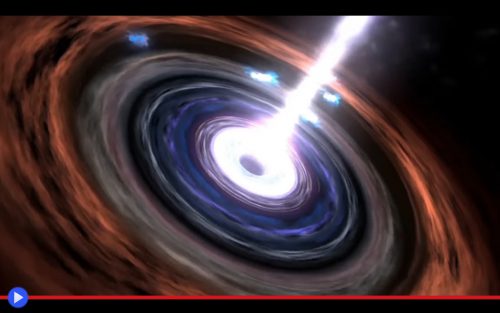Tutto appariva normale, nel braccio periferico del disco della galassia. Ma se lo si guarda da abbastanza lontano, è praticamente sempre così… Quale enorme supernova, che incomparabile disastro, potrebbe risultare abbastanza forte da scuotere in un dato momento l’agglomerato di un milione di stelle? Ogni cosa è importante, in senso cosmico eppure da un certo punto di vista, proprio per questo, quasi niente lo è davvero. Una simile situazione cambia radicalmente soltanto quando un evento si analizza nello specifico, dal particolare verso l’assoluto, immaginando il punto di vista di chi deve vivere (o non-vivere) con le conseguenze di simili cause spropositate. Eppure, come nel caso delle antipatie e differenze tra antiche divinità, che condussero a guerre apocalittiche nell’era delle antiche mitologie, nessuno poteva davvero profetizzarlo. Quando d’un tratto, trascorsi i canonici 26 milioni di anni, ritornò lui. L’astro cupo delle profondità galattiche, una silenziosa nana grigia dalle emissioni praticamente impercettibili, passando attraverso l’agglomerato della nube di Oort. Colui o colei che da sempre aveva condotto un’esistenza del tutto solitaria, senza influenzare o essere influenzato da chicchessia. Tranne che in quei singoli e rari, ma regolari casi, in cui oltrepassando il velo glaciale, era sbucata nell’oscurità oltre l’ultimo dei pianeti. Trascinandosi dietro una certa quantità di meteore e comete. Stiamo parlando, sia chiaro, di un qualcosa di largamente ipotetico. Una risposta, piuttosto che la domanda, relativa al perché, effettivamente, possa essersi verificata a più riprese l’estinzione di un parte significativa della vita terrestre. Che fa da corollario alla celebre teoria del grande impatto, andando ad analizzarne la remota e poco luminosa ragione: la vendetta di un fratello. Il ritorno di un dio offeso. Colui che nascendo assieme alla nostra stella, aveva avuto la peggio, crescendo debole e malaticcio.
Il come e perché ciò potesse essersi verificato, fin dall’elaborazione di questa sfrenata ipotesi verso la metà degli anni ’80 e la denominazione dell’oggetto col nome piuttosto suggestivo di Nemesis, sono rimasti largamente ignoti alla scienza. Finché lo scorso 28 aprile non è stato pubblicato, sul server online dell’università di Cornell, un nuovo studio realizzato da Steven Stahler, astronomo di Berkeley, e la sua collega Sarah Sadavoy, mirato a presentare un’analisi dell’indagine astronomica di tutte le protostelle della nube molecolare di Perseus, sita a circa 230 parsec dal nostro sistema solare, un’operazione denominata VANDAM (VLA nascent disk and multiplicity survey). La precisa catalogazione, sostanzialmente, di una vera e propria forgia galattica all’interno della quale si verificano la serie di reazioni e coincidenze alla base della nascita di un corpo astrale del tutto nuovo. Il procedimento dell’elaborazione di una statistica matematica, si sa, è la strana prassi per cui il frequente verificarsi di un qualcosa lo rende più probabile in futuro. Oppure, in casi ancora più privi di una logica generativa, si presume succedere l’esatto contrario. Fatto sta che all’ennesimo spalancarsi di una simile finestra sull’infinito, in molti casi la sola che abbiamo, è apparso evidente come la maggior parte delle stelle neonate di classe spettrale G2 di Perseus, ovvero le più simili alla nostra, apparissero come parte di un sistema binario distante. Il che voleva dire, sostanzialmente, che esse ruotavano l’una attorno all’altra, a una distanza di circa 500 unità astronomiche, che poi sarebbero 17 più della distanza che c’è tra il Sole e il suo ultimo pianeta, Nettuno. Questo perché, come ampiamente dimostrato dai radiotelescopi del New Mexico usati nel corso del sondaggio, per ciascuna formazione stellare era presente una concentrazione molecolare nota come “ammasso denso” simile a un uovo con due tuorli distinti. Talvolta più distanti, e quindi propensi a separarsi per l’effetto della forza centrifuga rotativa, e qualche altra invece estremamente vicini, inevitabilmente destinati a formare sistemi multipli come quello della vicina Alpha Centauri. Ma il caso del Sole e di Nemesis, per inferenza, dovrebbe essere ancora diverso, ovvero quello di una delle due parti che assorbe una simile quantità di materiale da subordinare la sua controparte, limitando le sue dimensioni sufficientemente da farla restare intrappolata nel suo campo gravitazionale. Con le succitate conseguenze che purtroppo, noi già ben conosciamo. È una strana correlazione di fattori, che ci permette di comprendere qualcosa del nostro più prossimo vicinato attraverso l’osservazione di una realtà sita ad oltre 700 anni luce di distanza. Il che significa, incidentalmente, che stiamo osservando il passato. Ma questo, come si dice, è tutto un’altro paio di maniche…
scoperte
La cavalcata robotica dei ragni rotolanti
In associazione al concetto stesso di un ragno che debba vivere nel vero deserto, non può semplicemente trovare posto una ragnatela. Poiché dove potrebbe mai assicurare i suoi fili, il piccolo cacciatore, in assenza di alberi, strutture o pietre di alcun tipo… In luoghi come gli erg marocchini, dove le dune raggiungono i 150 metri di altezza, e si estendono ininterrotte per oltre 50 Km, di calore battente, pioggia pressoché nulla e nonostante questo, popolati da una pluralità di piccole forme di vita. Primariamente rettili ed insetti, qualche mammifero, nonché naturalmente, l’aracnide occasionale. Non mancano mai! Che per quanto sopra delineato, non può che appartenere a una specifica famiglia: gli Sparassidae, o ragni cacciatori. Che come loro prerogativa, giammai costruiscono casa sopra il livello del suolo, ma piuttosto scavano in profondità, fino a 50 cm nella terra friabile che costituisce il terreno bruciante, per rifugiarsi dal sole infuocato e i loro molteplici nemici naturali. Un valido approccio, per sfuggire a cose volanti, striscianti o dotate di zampe artigliate, ma non al più temibile di tutti i nemici, ovvero la vespa pompilide, che una volta fiutata la presenza della sua vittima ad otto zampe, inizia a scavare, la sorprende nel buco e la punge, per deporvi all’interno le uova. Una morte terribile, quindi, aspetterà il ragno, che qualche settimana dopo sarà divorato da tali fameliche larve, in una ragionevole approssimazione della più celebre scena del film Alien. Ma l’evoluzione può mancare svariati bersagli, tranne quello fondamentale dell’imparzialità: e così mentre dotava il ronzante assassino delle sue armi, faceva dono a determinate specie di una valida speranza di salvezza: la capacità di balzare fuori e trasformarsi in una valanga.
Quando Ingo Rechenberg bio-robotista di Berlino nato nel 1934, si recò nel 2006 per l’annuale viaggio in Nord Africa, con l’obiettivo di testare le sue ultime invenzioni sulla sabbia friabile di tali luoghi, grande ostacolo di qualsiasi metodo di locomozione artificiale, non si aspettava certo di trovare la sua ispirazione durante una passeggiata notturna nell’Erg Chebbi, quando la sua potente torcia si ritrovò ad illuminare qualcosa sul bordo della duna. Un piccolo ragno che raccolse con le sue stesse mani e trasportò fino al campo base, dove ebbe modo di identificarlo in un primo momento come appartenente alla specie già nota del Cebrennus villosus. Se non che la mattina, mentre faceva colazione, l’aracnide riuscì ad eludere il recipiente in cui era stato intrappolato, appoggiò le sue zampe anteriori sul terreno e sollevò il deretano. Per poi completare la prima capriola, ed iniziare a prendere velocità. La vista era semplicemente incredibile, al punto che il New York Times riporta l’aneddoto secondo cui il professore si sarebbe commosso fino alle lacrime nel prendere atto dell’ingegno della natura, mentre gli ingranaggi della sua mente iniziavano a roteare a ritmo con l’ospite ormai lanciato a 2 metri al secondo verso le distanti radici dell’alba. Passano mesi, tra le insuperabili pareti della civiltà mondana, mentre l’inesauribile inventiva di quest’uomo non trova nuove improbabili applicazioni. Tra cui il robot Tabbot, vagamente simile all’essere mitologico del triskelion, una testa centrale con tre gambe disposte attorno alla sua circonferenza, secondo quanto raffigurato convenzionalmente, tra gli altri luoghi, sulla bandiera della Sicilia. Che in questa versione, d’altra parte, mostrava l’elemento dominante di una doppia ruota in plexiglass, con all’interno l’elettronica e i motori necessari a far roteare i tre arti pieghevoli, in grado di garantirgli un’ottima mobilità sul suolo dell’erg. Una creazione molto evidentemente ispirata dall’aspetto ed il modus del ragno. A cosa potrebbe servire, dunque? Rechenberg cita l’impiego in agricoltura, idraulica ma soprattutto, la futura esplorazione di pianeti lontani, dove un movimento affidabile su terreni accidentati potrebbe determinare la buona riuscita della missione. Ciò che costui non si aspettava, tuttavia, e probabilmente neppure noi, era che il suo nome sarebbe stato immortalato non tanto per l’opera continuativa di una vita intera, nella costruzione di ammirevoli dispositivi autonomi, quanto la scoperta accidentale di una singola sera. Così nel 2008, dopo molto cercare, lo scienziato veterano riuscì ad accaparrarsi un secondo ragno salterino e decise di trasportarlo, questa volta mediante l’impiego di un vaso ermetico, fino allo studio dell’aracnologo Peter Jäger, presso l’Istituto di Ricerca e il Museo di Storia Naturale di Senckenberg. Dove un’osservazione più approfondita della creatura, ed in particolare la conformazione dei suoi genitali, permisero di classificarla come l’olotipo di una specie del tutto nuova, che venne proprio in onore del suo scopritore ricevette l’appellativo scientifico di Cebrennus rechenbergi. E quello pensato per l’uso comune di “ragno flic-flac” per rendere onore al suo singolare, ed occasionale metodo di locomozione, tanto simile a quello dei ginnasti olimpionici durante le loro esibizioni. Che per la cronaca, non fu mai brevettato…
La scienza può spiegare una cascata di sangue?
Ormai prossimi allo sfinimento per il gelo e le difficoltà incontrate, i geologi facenti parte della spedizione Terra Nova erano partiti da Butter Point il 26 gennaio del 1911, con l’obiettivo di raggiungere la zona ad ovest del canale di McMurdo, ancora largamente inesplorata. Nella storia delle grandi esplorazioni, l’Antartide ha avuto spesso questo effetto: la capacità di richiamare, coloro che avevano già speso le loro più preziose risorse sempre più in profondità, con una voce stentorea che pare provenire dalle viscere del mondo stesso. Quattro giorni dopo, ormai sfiniti per la marcia ininterrotta, Griffith Taylor, Debenham, Wright ed Edgar Evans si trovarono dinnanzi a uno spettacolo del tutto inaspettato. Il terreno in discesa, che si trasformava in una valle. Ed all’interno di questa, la quasi totale assenza di ghiaccio. Costoro non potevano sapere, all’epoca, di essere al cospetto di un fenomeno altamente specifico di tali luoghi. I forti venti catabatici, a velocità di oltre 320 Km/h, che nel discendere si scaldano in maniera significativa. Garantendo temperature non più basse di 0 -5 gradi in estate, contro i -25 medi del più meridionale dei continenti. E un’umidità quasi del tutto assente. Ovunque, tranne che in prossimità dei laghi: Vida, Vanda, Brownworth… Bonney. Nomi semplici e apparentemente familiari, per alcuni dei luoghi più salini della Terra, con concentrazioni molto superiori addirittura a quelle del Mar Morto. Nonché uno spettacolo ancor più macabro, in apparenza, di quel nome in grado di annientare la speranza di un domani. La cascata rosso sangue, alta quanto un palazzo di cinque piani, che soltanto periodicamente si palesa dalla roccia del ghiacciaio sopra il lago Bonney, mischiando il proprio flusso con le acque di quest’ultimo, in un lento turbinìo. L’impressione che si ha, di fronte a un simile titano, è di aver trovato l’evidenza di un’ecatombe. Se non fosse che quell’acqua scorre da millenni, eoni interi, e per quanto ne sappiamo, neppure siamo giunti alla metà della sua storia.
Ne parlò l’autore H.P. Lovecraft, nei suoi romanzi sugli dei venuti dalle stelle all’epoca della preistoria umana: ciò che dorme, risparmiando le sue forze, può restare vivo per l’eternità. In attesa che qualcuno, incautamente, giunga a disturbarlo con la sua presenza largamente indesiderata. Durante l’Era Proterozoica (2500-541 milioni di anni fa) la vita sulla Terra subì un significativo contrattempo: tutti quei batteri ed animali rudimentali, che ormai brulicavano su ogni superficie orizzontale, stavano generando quantità impressionanti di anidride carbonica. Ma le piante in grado di riciclarla, per produrre ossigeno, non erano ancora presenti in quantità adeguata. Così finì quel delicato esperimento. O quasi. Perché la vita, tenace come è sempre stata, trovò il modo di salvare se stessa, permettendo lo sviluppo di alcune forme totalmente nuove, in grado di prosperare anche in assenza di un ambiente che potesse dirsi a loro misura. Erano questi gli estremofili, creature microscopiche, racchiuse in gusci solidi, che si ritirarono del tutto dalla luce del distante Sole. Imparando a trarre il loro nutrimento dalle semplici sostanze chimiche dell’acqua che scorre nelle profondità del mondo. E potrà sembrarvi folle, eppure esse, sono ancora lì. All’interno di un brodo primordiale che non si è evoluto, semplicemente perché ha raggiunto il proprio massimo potenziale quando il mondo aveva un solo continente, o poco più. Ed oggi, la loro casa è stata finalmente mappata grazie allo strumento della tecnologia…
“Svelato il mistero della Cascata di Sangue” hanno titolato le testate internazionali a seguito della pubblicazione, avvenuta pochi giorni fa, dello studio condotto dalla studentessa Jessica Badgeley del Colorado College, assieme alla glaciologa Erin Pettit dell’Alaska Fairbanks e il suo team, finalizzato all’impiego di una coppia di antenne radar per raggiungere i più occulti pertugi sotto un simile ghiacciaio, alla ricerca di nuovi indizi sul suo complesso funzionamento. Mentre la realtà è che questa nuova spedizione, condotta grazie agli strumenti veicolari odierni, che hanno reso l’esplorazione dell’Antartico un’impresa assai mondana, non ha introdotto proprio alcunché di TOTALMENTE nuovo. Sono ormai diverse decadi, che è stata smentita l’ipotesi secondo cui l’acqua avesse tale colorazione a causa della presenza di un’alga, come pure è nota, almeno dal 2014, la presenza di un secondo vasto lago mantenuto liquido dal sale, posto tra la superficie e il piano della roccia sottostante. Il quale, con la sua alta concentrazione di ferro elementale, è la ragione della formazione della vera e propria “ruggine” mischiata all’acqua, che poi sgorga periodicamente al verificarsi delle giuste condizioni. Ciò che veramente cambia, oggi, è che per siamo finalmente in grado di sapere quali siano queste condizioni…
Gli studiosi chiariscono il mistero della forgia dei Soli
Fondamentale risulta essere in filosofia la distinzione tra l’infinita grandezza e l’infinita potenza di un qualcosa, perché se da una parte è facilmente possibile immaginare uno spazio che non si esaurisce mai (molto più complesso, piuttosto, è concepire il nulla che dovrebbe circondarlo) risulta molto evidente che la capacità di modificare la realtà appartiene al concetto largamente religioso di un Essere Supremo, che non può essere provato o cancellato dalla logica, semplicemente perché appartiene al puro regno della Fede. Oppure…No? Se soltanto prendiamo in analisi quell’insignificante fetta di universo che si trova alla portata dei nostri occhi scrutatori, si inizia a sospettare una profonda ed assoluta verità: che più un qualcosa si estende nello spazio, maggiormente sembra in grado di esercitare l’effetto di una remota e inconoscibile volontà. L’attrazione gravitazionale che determina il passo delle orbite dei pianeti, il passaggio regolare e cadenzato delle comete, l’occhio nero come la pece che genera fiammate sito nel centro esatto della Via Lattea… Tutto avviene per una ragione, quella ragione, se vogliamo, può essere definita suprema fatalità del cosmo. Prendete ora, per un attimo, come vera tale sfrenata ipotesi. Dove si troverebbe, dunque, l’esistenza più possente di tutte? Difficile capirlo, va pur detto. Ma ne conosciamo alcune che ci vanno particolarmente vicino… Come l’ammasso di galassie della Fenice o SPT-CL J2344-4243, sito a 5,7 miliardi di anni luce dalla Terra e ne occupa 1,1 fino ai suoi più distanti confini. Che risulta tuttavia facilmente misurabile, per le sue dimensioni totalmente spropositate: 2 x 1015 masse solari, abbastanza da causare un picco nei rilevamenti dell’impianto di radiotelescopi ALMA, sito nel deserto di Atacama in Cile, o disegnare una chiara impronta sulla scansione a raggi X del Chandra, telescopio portato in orbita nel 1999, durante uno degli ultimi voli dello Space Shuttle Columbia, nave spaziale andata incontro ad una fine tragica nel 2003. Tanto che nel corso delle prime due settimane di febbraio, come coronamento di un lungo studio dei dati raccolti, un team di scienziati formati in parte da ricercatori del MIT e dell’Università di Cambridge ha pubblicato un articolo sull’Astrophysical Journal che potrebbe gettare luce su una delle proprietà più particolari di questo e molti altri luoghi del cosmo, inclusa la via Lattea che abbiamo l’abitudine di chiamare casa. Proprio così: sto parlando della capacità di crescere, generando una quantità variabile di nuove stelle.
È una questione largamente nota, in effetti, che il nostro Sole ed i suoi innumerevoli simili vadano incontro ad un ciclo vitale chiaramente definito, per cui all’esaurimento del combustibile che ha generato la loro stessa esistenza, esse si spengono o ancor peggio, esplodono e collassano in qualcosa di eccezionalmente piccolo e pesante. Per lo meno, all’inizio… Come sarebbe possibile, dunque, che nel cielo risplendano ancora innumerevoli costellazioni, nonostante l’antichità dimostrabile della materia, per come possiamo dire di conoscerla e comprenderne il funzionamento? Se la morte non fosse un qualcosa di diametralmente opposto alla fine, dando l’inizio ad una nuova sinfonia della Creazione, un qualcosa di così pericolosamente vicino al concetto di un Dio rinato. Prendete atto, dunque, dell’insospettabile realtà: al centro di SPT-CL J2344-4243, in corrispondenza dell’occhio dell’uccello mitologico da cui l’ammasso prende il nome, è sita una galassia di proporzioni pressoché normali, che risulta essere tuttavia il singolo oggetto più luminoso verso cui siano mai stati puntati gli strumenti e i telescopi della Terra. La ragione di tale anomalia è da ricercarsi nella natura stessa del suo nucleo: un buco nero supermassiccio equivalente approssimativamente alla grandezza di 20 miliardi di Soli, tanto è riuscito attraverso gli eoni ad attirare verso di se incalcolabili quantità di materia. Ora noi siamo abituati a pensare, grazie a quanto ci è stato insegnato da generazioni di romanzi e film di fantascienza, che nulla possa sfuggire all’attrazione gravitazionale di un simile luogo, dove la fisica cessa di esistere per come l’abbiamo conosciuta fino ad ora. Mentre a tutto c’è un limite e la realtà dei fatti non potrebbe essere più diversa.