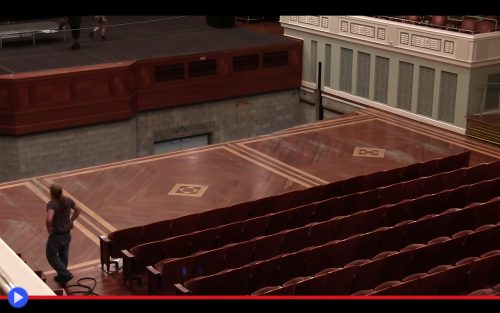Fa freddo nel cortile del WeeGee Exhibition Centre, ad Espoo in Finlandia, fra il fruscìo della vegetazione rigogliosa piantata tutto attorno a una tipografia dismessa ormai da circa vent’anni. Ma lo sguardo, per lo meno, è riscaldato da un’inconciliabile visione: una bizzarra capsula di quattro metri di diametro, sospesa da terra, costellata di oblò equidistanti sopra la livrea di un vistoso color giallo zafferano. D’un tratto, con un sibilo meccanico, uno spicchio dell’oggetto si apre, rivelando una rampa ribaltabile del tutto simile a quella di un aereo. Un paio di piedi iniziano a discenderla, per diventare quindi gambe, vita e inevitabilmente, un volto. Gli occhi grandi, la folta barba… L’avete riconosciuto? Si tratta, senza alcuna ombra di dubbio, di…
Se guardiamo al domani adesso, tramite la lente della letteratura o del cinema di fantascienza, tendiamo a percepire una distesa desolata al cui confronto gli aridi deserti paiono dei prati alpini. Morte, povertà e devastazione. L’armonia del consorzio umano ormai un remoto ricordo, mentre le persone si combattono per le ultime risorse di un pianeta ormai stanco, battuto dai mutanti, dagli alieni e dagli spiriti affamati di rivalsa. Mentre tutto ciò che popola le nostre fantasie, in qualche maniera, lo riflette: le auto corazzate di Mad Max, le armi mostruosamente letali dei romanzi di William Gibson, i vampiri mangiatori di carne umana di Io Sono Leggenda… Mentre per quanto concerne l’architettura, è raro che i creativi si dilunghino eccessivamente nelle descrizioni. Il che è piuttosto logico, a pensarci: perché quale diamine potrebbe mai essere, l’aspetto di una casa concepita per ospitare una persona ragionevole all’interno di una tale distopia? Se non un cubo di cemento, privo di finestre tranne quelle per prendere la mira, tutto spigoli e filo spinato, dietro varchi successivi di porte blindate e trappole letali! Le abitazioni del domani in fiamme, per come lo vediamo tristemente oggi, non presentano sorprese di alcun tipo. Né la benché minima traccia di linee curve. Ma di contrasto, fino all’altro ieri non fu così. Quando la strada innanzi a noi pareva luminosa e corroborata dal bagliore dell’ottimismo mentre la plastica, materiale indistruttibile ed innovativo, trovava applicazione in ogni ambito che voi possiate concepire. Incluso quello, strano a dirsi, abitativo. Per lo meno in base alla visione operativa di Matti Suuronen, architetto finlandese celebre per l’uso che faceva di poliestere, resine termoindurenti, acrilico e fibra di vetro. Tutti materiali che trovarono l’applicazione nella sua visione di una casa ideale, o per usare l’effettivo marchio commerciale usato a partire dal 1968, l’adorabile Futuro house.
Immaginate, se potete, un’epoca di surplus finanziario, durante la quale ogni famiglia disponeva di risorse in eccedenza. Quando praticamene chiunque, persino i lavoratori con stipendio minimo dell’allora neonato Walmart, era PER LO MENO benestante. Ciò perché i soldi, quei pezzi di carta privi di una reale utilità nel mondo fisico, potevano giovarsi di un potere d’acquisto che cresceva in modo esponenziale. Tanto che ben presto, fluttuando sulle fantasie sui viaggi nello spazio, la robotica, l’idillio di una società pacifica che accelerava i suoi progressi, si iniziò ad immaginare un 2000 in cui nessuno avrebbe più avuto bisogno di lavorare, se non per scelta personale, e tutti avremmo avuto bisogno di un luogo in cui divertirci per far passare i lunghi mesi di una vita senza impegni. Ora, i modi chiaramente non mancavano. Ma il buon Suuronen, a quanto ci è possibile immaginare, amava soprattutto questo: sciare. Così il suo più celebre contributo generazionale, verso il volgere del decennio, fu l’idea per un nuovo tipo di baita per la montagna, non più concepita per essere faticosamente messa insieme sul posto, grazie al sudore sulla fronte delle maestranze locali, bensì costruita in fabbrica in qualche decina di pezzi, da far assemblare al personale tecnico in un paio di giorni, o in alternativa, addirittura, trasportata tutta intera con l’ausilio di un prestante elicottero. Il che doveva presentare una visione piuttosto bizzarra. Perché vedete, la Futuro house è costruita con la precisa forma di un disco volante. Si tratta di una mera coincidenza, intendiamoci. Di una forma concepita, nelle parole dello stesso creatore, per massimizzare l’isolamento termico e risultare, al tempo stesso, in grado di lasciar scivolare via la neve dal tetto, potendo in aggiunta contare sul solo appoggio di quattro palafitte, soluzione ideale in condizioni di suolo instabile o roccioso. Ma l’illusione non può che persistere immutata…