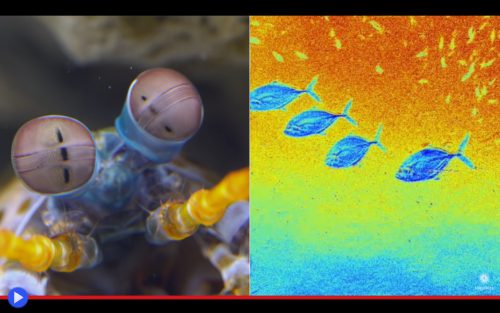Normalmente, moderno vuol dire costoso e le soluzioni tecniche più avanzate sono inevitabilmente quelle maggiormente desiderabili all’interno di un prodotto di ultima generazione. Un esempio? Molti ricordano con entusiasmo e nostalgia l’epoca trascorsa dei “bei vecchi Nokia 3310” che telefonavano soltanto, ma “lo facevano dannatamente bene!” Eppure ben pochi, persino tra coloro che declamano un simile motto come verità divina, sarebbero pronti a barattare il proprio modernissimo smartphone per l’indistruttibile (o così si dice) mattone blu-cobalto norvegese. Basta, del resto, inoltrarsi per qualche minuto nel favoloso mondo patinato del lusso, per trovare un andamento delle cose essenzialmente all’incontrario. Meno una cosa appare pratica da utilizzare e/o produrre, tanto più è desiderabile, nonché costosa, mentre di pari passo c’è un legame indissolubile con un principio che sussiste da epoche remote: la visione universale del bello. Ed è un momento assai particolare ed importante, nella vita di un’azienda tecnologica, quello in cui si scopre di aver raggiunto una base sufficientemente solida, dal punto di vista della reputazione e della sicurezza finanziaria, da potersi avventurare nella produzione di un qualcosa che non ha sostanzialmente nessun tipo di predecessore. Ciò che ne deriva, in via collaterale, è sempre un video che procede per sommi casi, così.
In una delle proposte ad Internet più popolari nella storia del canale ufficiale su YouTube della compagnia dell’audio giapponese Fostex, diventata famosa oltre 30 anni fa grazie alla produzione di componenti per altoparlanti professionali, veniamo invitati a prendere visione del processo di rifinitura esteriore di uno dei suoi prodotti più eclettici ed originali: le cuffie TH900, ricoperte grazie alla metodologia antichissima della laccatura urushi, una forma d’arte originaria unicamente di questo paese, e praticata fin da tempo immemore all’interno di questo stabilimento del villaggio di Sakamoto (prefettura di Suruga) da cui scaturisce anche un’ampia varietà di penne, orologi, utensili di vario tipo e ciotole tradizionali. A tal punto, ancora oggi, è straordinariamente popolare ed apprezzata in tutto l’arcipelago una simile soluzione per proteggere ed al tempo stesso abbellire gli oggetti, le cui prime attestazioni archeologiche risalgono addirittura all’era preistorica del periodo Jōmon (10.000 – 300 a.C.) Sarà dunque opportuno specificare cosa, in effetti, distingua questo metodo di laccatura estremo-orientale da quello in uso qui da noi fino al tardo Rinascimento europeo e che traeva origine dall’India, consistente nel creare l’eponima vernice trasparente grazie a copiose quantità della secrezione dell’insetto lākshā, un tipo di cocciniglia degli alberi. Mentre la lacca giapponese, dal canto suo, ha un’origine esclusivamente vegetale come esemplificato anche dal video della Fostex, e si produce a partire dall’alberodel Toxicodendron vernicifluum, uno stretto parente dell’edera velenosa, in grado di indurre reazioni allergiche piuttosto gravi nell’uomo.
Si nota subito in effetti nelle prime battute del video la tenuta estremamente coprente dell’uomo incaricato di praticare le incisioni negli arbusti designati a un tale compito ingrato, ed ancor maggiormente nel suo collega impastatore, che all’interno dello stabilimento indossa guanti e camice protettivo degni di un’istituzione di tipo nucleare. Basterebbe infatti una singola goccia della resina sul corpo, ancora pressoché grezza in questa fase e contenente il principio attivo dell’urushiol, per infliggerli vesciche simili ad ustioni, comprensibilmente molto dolorose. Il semplice fatto che un simile processo di lavorazione, in effetti, sia stato integrato in una logica industriale con alti volumi di produzione è già di per se affascinante. Ma aspettate di vedere ciò che succede di lì a poco…