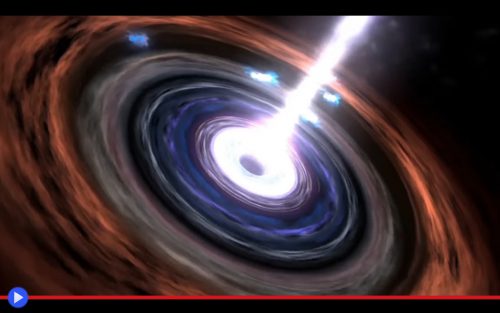Osservando la scena dallo schermo del suo radiocomando, l’operatore non poté fare a meno di restare brevemente a bocca a aperta. Quasi come se, pur conoscendo l’origine dello strano fenomeno continuativo nel tempo, egli non riuscisse a venire a patti con la sua esistenza e le mani minacciassero di prendere il controllo autonomo del Phantom Drone, oltre 1.000 dollari di delicata, avanzatissima tecnologia appartenente al dipartimento Ricreazione e Parchi della contea di Napa. Così ad ondate successive, dapprima timidamente, quindi con maggior coraggio e chiaro sprezzo dell’autoconservazione robotizzata, il quadricottero con telecamera parve avvicinarsi al grande vortice di esattamente 22 metri di diametro, nel tentativo di riprendere dal basso le sue pareti verticali d’acqua scrosciante e furibonda, intenta a nascondersi dalla luce soprastante del Sole. L’appel du vide: il richiamo del vuoto, che tante vittime ha mietuto attraverso la storia dell’umanità, portando uomini e donne in perfetta salute mentale a lanciarsi dai piani più alti di un palazzo o le pendici di un dirupo, alla ricerca della sensazione molto breve ma monumentale del volo umano. Del resto, qui tutti conoscono la storia: della donna che nel 1997, nuotando in prossimità del Glory Hole, ne venne risucchiata, precipitando per 60 metri al fondo del lago. Ma non è davvero possibile, che fosse successo per caso: tutti sanno che è severamente vietato nuotare in prossimità della voragine mostruosa. Mentre gli scrosci aumentano d’intensità, il ronzante dispositivo radiocomandato s’inclinò lievemente per l’impatto degli schizzi d’acqua, ormai davvero troppo vicini. Improvvisamente riportato all’attimo presente, l’operatore intervenì sui comandi, nella speranza di riuscire a salvare il drone. Sullo schermo, nel frattempo, il buco s’ingrandiva, sovrastando ogni altro elemento del paesaggio: “#§@!#&! Il mio capo mi ucciderà.” Pensò egli ad alta voce, mentre un’anatra distante faceva eco all’irripetibile locuzione.
California, hai detto? California, lo stato in cui l’acqua scarseggia periodicamente, lasciando persino le grandi città come San Francisco e Los Angeles costrette a razionare l’acqua durante i mesi più caldi dell’estate? Possibile che tra tali confini, dalle caratteristiche idrografiche normalmente avverse, possano presentare il problema di un lago che minaccia di tracimare, inondando intere comunità incolpevoli e comunque, da sempre contrarie a costruire quella diga? La risposta, dopo lo sfiorato disastro della diga di Oroville la scorsa settimana, penso sia davvero sotto gli occhi di tutti. Il più popoloso e grande stato della costa Occidentale, che si estende per 1240 Km tra l’Oregon e il Messico, è un concentrato di climi e situazioni ambientali estremamente vari: deserti, foreste, montagne… E il clima di un simile luogo, parimenti, non poteva che essere mutevole come un colubride con il sonaglio sulla punta della coda. Succede così, per usare un detto tipicamente americano, che “When it rains, it pours” (quando piove è un diluvio) e ciò che è stato tanto attentamente costruito nel corso del secolo scorso, al fine di fornire l’energia idroelettrica ai luoghi sopracitati, debba necessariamente essere messo alla prova, senza alcun riguardo per il suo valore storico, l’arretratezza delle soluzioni adottate, i cambiamenti sopraggiunti lungo il corso diseguale dell’ingegneria. Ogni anno, più o meno puntualmente, succede. Che l’acqua superi quella voragine perennemente spalancata, decidendo, per l’effetto dell’inamovibile forza di gravità, di precipitare entusiasticamente al suo interno. La scena, vista dall’alto ma anche dal livello del suolo, si presenta come un’impossibile miraggio delle circostanze.
Ora, naturalmente, la diga ad arco di Monticello costruita tra il ’53 e il ’57 lungo il corso del Putah Creek, per creare il lago artificiale Berryessa presso le pendici delle Vaca Mountains, non è nulla di speciale al confronto del sopracitato terrapieno inclinato di Oroville, barriera idrica più alta degli Stati Uniti: 93 metri Vs 235, per 312 di lunghezza contro gli oltre due Km della collega, sita ad appena due ore di macchina verso la città di Reno. Ma io credo che una volta superato il punto di vista delle mere statistiche, da questo luogo architettonicamente significativo emerga un fascino nostalgico del tutto comparabile e persino superiore all’altra. Il fatto che non abbia ancora minacciato di crollare rovinosamente dall’inizio del 2017, tra l’altro, è un grosso punto a favore.