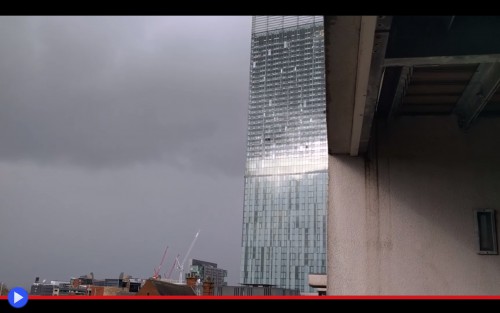I locali la chiamano la second community, ovvero in altri termini, una città oltre gli spazi abitativi ma totalmente conforme alla loro invisibile presenza. Fatta di tragitti attentamente designati, che conducono a perdersi in mezzo alle sabbie del Mojave. Se visualizzati grazie all’occhio della mente, interi quartieri paiono configurati sullo schema del tipico sobborgo americano, con villette a schiera, strade ordinate e una gremita zona per gli acquisti, connotata dalle voci di famiglie in festa poco prima il giorno di Natale. Ma dal punto di vista propriamente detto, in questi luoghi ci sono soltanto polvere, qualche casa rovinata, occulti nidi di scorpioni. Oltre il concetto della proverbiale cattedrale nel deserto: un’intera città, sperduta, lì.
L’aspetto maggiormente trascurato nella concezione Europea degli Stati Uniti è la quantità di spazi vuoti che compongono quel vasto territorio, fatto indubbiamente, delle grandi metropoli più celebrate, come New York, San Francisco, Los Angeles… Ma anche di chilometri e chilometri di un assoluto ed assolato nulla. Per chi vive in quegli ambienti, ciò è un assunto pressoché essenziale della vita stessa: trasferirsi per lavoro non significa il più delle volte, cambiare quartiere, o prendere in affitto una casa a qualche centinaio di chilometri dalla propria dimora nascitura; bensì imbarcarsi su un aereo, per raggiungere un luogo che si trova alla distanza equivalente da Parigi-Mosca, o Berlino e Madrid. Soltanto così può trarre l’origine quel fenomeno tipicamente americano, ma che in questi ultimi tempi sta prendendo piede pure in Cina, di definire uno spazio arbitrario come pietra angolare di un’intera metropoli, poi chiamarla tale, almeno sulla carta, ed aspettare che la gente giunga a costruire case, pompe di benzina, centri commerciali…Una vera e propria trasformazione del territorio, in cui l’investimento di partenza agisce come una scintilla, finalizzata a scatenare l’incendio del mercato immobiliare. Il che descrive per sommi capi, incidentalmente, l’opera compiuta a partire dagli anni ’60 dall’imprenditore cecoslovacco naturalizzato americano Nathan (Nat) K. Mendelsohn, originariamente un sociologo e professore all’università newyorkese di Columbia, poi trasformatosi nel profeta economico di quella che doveva diventare, nella sua visione, ovvero una nuova singola città più grande dello stato.
Si, ma come? Non è esattamente chiara alle cronache, per lo meno quelle internettiane, dove l’uomo avesse trovato i 500.000 dollari necessari per acquistare nel 1958 dal governo 82.000 acri di deserto siti a 100 miglia a nord di Los Angeles, poco più del doppio a sud ovest di Las Vegas, dopo aver notato durante un viaggio d’intrattenimento come il ranch locale di M&R disponesse di nove pozzi artesiani, i quali miracolosamente non esaurivano mai l’acqua. Mentre sappiamo molto bene, ciò che venne immediatamente dopo: una campagna pubblicitaria spietata, a mezzo stampa e radiotelevisivo, mirata a presentare la nascente California City come il segno e il passo del futuro. “Approfonditi studi demografici hanno dimostrato che la popolazione della California è destinata a raddoppiare (quadruplicare, triplicare…) nel corso di un paio di generazioni. Acquistare un terreno qui, adesso, significa mettersi sulla strada del futuro!” Verso il mese di marzo di quello stesso anno, il progetto iniziò a prendere forma. Procuratosi l’aiuto dell’esperto pianificatore urbanistico Wayne R. Williams, Mendelsohn fece tracciare il disegno di una vera e propria città modello, con scuole, biblioteche, musei e ogni altro possibile servizio a vantaggio di un luogo concepito dichiaratamente a misura d’intellettuali. Le strade portavano il nome di scienziati e filosofi, oppure grandi industriali, mentre ampi spazi erano già stati designati per parchi e zone verdi, che sarebbero stati irrigati grazie alle corpose falde acquifere con origine sotto i monti della vicina Sierra Nevada. I primi 876 lotti furono quindi messi in vendita, durante il mese di maggio, venendo esauriti nel giro di pochi giorni. Ma questa non era che una parte minima, del totale territorio acquisito dal sognatore cecoslovacco. Considerando come il valore medio per un appezzamento abitativo si fosse riconfermato sul mercato come pari a circa 1.000 dollari cadauno, potrete facilmente comprendere l’enorme potenziale commerciale della cosa.
A quel punto, il limitatore del marketing fu delicatamente rimosso, per non dire scardinato con furia dal possente desiderio di veder crescere dal nulla il fiore metropolitano: tra giugno e dicembre, con l’apertura alle offerte per altri 427 lotti, seguiti dalla rapida approvazione della contea di Kern per altri 900, interi pullman di potenziali acquirenti furono guidati fino al sito di California City, con tutte le spese coperte dalla compagnia di Mendelsohn, mentre addirittura un grosso aereo DC-3, ospitante al suo interno alcuni tra gli investitori maggiormente fortunati, venne fatto atterrare in mezzo al deserto, presso il sito stesso del futuro centro cittadino. Venne quindi donato un terreno a quella che sarebbe diventata la prima scuola elementare, mentre si stendevano i cavi della luce e sotterravano i tubi dell’acqua sotto il suolo del deserto stesso. Entro la fine dell’estate, prevedibilmente, alcune case iniziarono timidamente ad essere costruite. Pensate a quel momento topico, nella costruzione virtuale di un insediamento all’interno di videogiochi alla Sim City, quando avete già disposto le strade del vostro primo vicinato, collegato i servizi fondamentali e designato zone verdi (residenziali) azzurre (commerciali) e gialle (industriali). Quando, se tutto è stato fatto correttamente, gli edifici inizieranno a sorgere in modo spontaneo, spinti da quell’inarrestabile forza generatrice che è l’edilizia a conduzione privata. Oppure, non succede assolutamente nulla e voi finite in bancarotta per le spese, nel giro di 10 minuti trascorsi a velocità iper-accelerata.
urbanistica
Che cosa è peggio di un palazzo ululante
Presso la ridente cittadina di Terrace, lungo il corso del fiume Skeena nella Columbia inglese, tra sequoie secolari. Presso il Giardino d’Inverno di Homel, un centro abitato bielorusso non così distante dalla centrale di Černobyl, che all’epoca dell’incidente irradiò terribilmente la regione. A Houston. A Denver. Di nuovo, Kiev. In luoghi urbani o in mezzo alla natura più selvaggia; all’ombra di montagne o in larghi spiazzi pianeggianti e in un periodo che si estende, grosso modo, dal 2005 all’anno attualmente in via di conclusione, durante il quale questo fenomeno è stato più forte che mai. Una questione definita a più riprese come “Lo strano suono udìto in vari luoghi della Terra”. Nelle descrizioni dei video che ne sono stati tratti per YouTube, letteralmente centinaia, si affollano le spiegazioni più improbabili: chi lo definisce simile a un UFO che atterra, altri vi riconoscono le trombe stesse dell’Apocalisse. Ma in realtà, era soltanto il vento.
Il fatto stesso che possa nascere una simile diatriba, in un’epoca e un millennio tanto proiettati verso il futuro, è l’ennesima dimostrazione di quante variabili influenzino l’ambiente naturale e di come persino una cosa tanto familiare, che da sempre esiste e che dovremmo conoscere davvero molto bene, possa coglierci del tutto impreparati nelle sue infinite variazioni. E come l’occulta complicazione riesce a colpire e tanti improvvisati scopritori del sovrannaturale, lo stesso avviene per chi progetta ambienti per mestiere, l’estremamente informato, sempre attento autore di edifici. Architetti che studiano per una vita carichi e portate, iconostasi e impiantiti, fino all’acquisizione di un preciso repertorio di quello che può essere idealmente costruito, in determinate condizioni e nello spazio disponibile per il progetto, fino a perdere di vista a questione del SE, fosse davvero il caso di dare una forma a una particolare cosa. È una situazione veramente sfortunata. Si tratta di un incidente di percorso che difficilmente si poteva prevedere. Una dannazione, terribilmente persistente, che ha colpito gli abitanti di Machester a partire dal 2006, con la conclusa costruzione della Beetham Tower, uno dei grattacieli più sottili il mondo, nonché il 12° più alto dell’intero Regno Unito, superato unicamente dai colossi edilizi della capitale. Si tratta di una storia, lanciata dai giornali locali per la prima volta poche settimane dopo l’inaugurazione, che periodicamente viene fatta rimbalzare ad opera agenzie di tutto il mondo, cogliendo sempre in contropiede l’opinione pubblica distante, che mai e poi mai, si sarebbe immaginata l’esistenza di un simile problema. Che a conti fatti, se davvero vogliamo considerare le remote implicazioni, non è neppure la peggiore inaspettata caratteristica di un alto palazzo inglese, quando si considera l’alternativa ancora più terribile del 20 Fenchurch Street di Londra, che invece d’incanalare l’aria si dimostra il dominatore di un ben più problematico elemento…Ma non affrettiamoci eccessivamente. Prima di analizzare l’alternativa, vediamo esattamente che cosa sta succedendo nella città che fu celebre per la sua produzione tessile meccanizzata, durante l’epoca della prima rivoluzione industriale.
La Beetham Tower, di proprietà dell’omonima compagnia d’investimenti, è il prodotto dello studio di architetti con sede locale SimpsonHaugh and Partners, e in particolare nasce dalla visione di Ian Simpson, uno dei principali fautori del grande rinnovamento urbanistico iniziato nel 1994. Parzialmente anche sua fu infatti l’opera di un piano per la ricostruzione del centro cittadino intitolata A Guide to Development in Manchester, concepito per ricongiungere in spazi comuni la parte sud della città, più ricca, con quella sita a nord. Un progetto fortemente voluto da Lesley Chalmers, direttrice del consorzio Hulme Regeneration Ltd. e che avrebbe portato, negli anni immediatamente successivi, al totale rinnovamento della storica area di Cathedral Street, con l’edificazione di una grande piazza e parco cittadino. Ma che non includeva, almeno in origine, il piano per un grattacielo alto 169 metri nel quartiere centralissimo di Deansgate, un qualcosa a cui la popolazione locale non poteva dirsi, nei fatti, ancora pronta.
Il piano fu infine proposto al Consiglio Comunale di Machester soltanto nel 2003, con il prestigioso supporto dell’English Heritage Trust, un’organizzazione accademica posta a tutela dei beni culturali. In breve tempo, fu dato il via libera e il grattacielo cominciò a prendere forma.
Il magico mulino della spazzatura
A dimostrazione che davvero, nonostante ciò che si potrebbe tendere a pensare, QUALCOSA può essere fatto; a memento ben visibile, costantemente spinto innanzi dalla forza inesorabile dell’acqua, di come l’ingegno costruttivo talvolta possa prendere strade inaspettate, ritornando a soluzioni tecnologiche di un altro tempo. La ruota di Baltimora. Che dal maggio del 2014, da quando è stata collocata nella sua posizione strategica presso il punto cui il torrente di James Falls s’incrocia con il fiume Patamsco, poco prima di sfociare nella laguna cittadina e quindi via, dritto nell’Oceano Atlantico, ha raccolto: 97.000 bottiglie, 80.000 sacchetti per le patatine, 4 milioni di mozziconi di sigarette. Oltre ad una quantità d’immondizia assortita che è stata stimata attorno alle 200 tonnellate, con alcune giornate record da 15 o 20 nel giro di 24 ore, in genere a seguito di una tempesta o altro tipo di disturbo meteorologico. Come avveniva in questo particolare caso, entusiasticamente illustrato da due figure chiave del progetto, Adam Lindquist, della Healty Harbor Initiative, e John Kellett, l’inventore ed a quanto sembra, occasionale custode del dispositivo, costruito grazie ai progetti della sua rinomata compagnia locale, la Clearwater Mills. Persone con un sogno, a dire poco, estremamente ottimistico: rendere la laguna di una delle città più inquinate degli Stati Uniti in proporzione ai suoi abitanti (“soltanto” 620.000 nell’area urbana principale) non soltanto migliore, ma addirittura adatta alla balneazione ed alla pesca, entro il termine stimato del 2020. Immaginate di sentirvi dire che potrete, di qui a qualche anno, gettarvi gioiosamente assieme alla famiglia nell’increspato fiume di una grande città italiana, come il Tevere di Roma. Ecco, sostanzialmente, ciò di cui stiamo parlando; un sogno all’apparenza impossibile, che deve prendere l’origine da un corso nuovo di pensiero. E questa Harbor Water Wheel, dal prezzo approssimativo di mezzo milione di dollari e ribattezzata colloquialmente con il nome di Mr. Ruota della Spazzatura, è certamente un primo valido passo verso la risoluzione del problema.
Già dall’estetica, che Kellet dichiara di aver concepito in un momento d’ispirazione, facendone un disegno sopra un tovagliolo di carta, si nota un chiaro intento d’innovare i presupposti preesistenti. La ruota, montata su una chiatta galleggiante, presenta una copertura in tela dagli elementi che la fa rassomigliare ad una sorta di animale preistorico, dotata di un funzionale apporto di pannelli solari sovrastanti. Che tuttavia, nelle giornate normali non vengono impiegati, come del resto neanche la batteria per l’accumulo energetico nascosta in compartimento impermeabile, poiché basta la sola forza idrica a far muovere le pale dell’eponimo dispositivo, immettendo forza motrice in un sistema d’ingranaggi che garantisce, indipendentemente dalle condizioni sussistenti, un lento procedere del meccanismo del nastro trasportatore. In alternativa, quando manca il vento e l’acqua si fa torbida, una pompa si occupa di sollevarla e farla ricadere sulla parte superiore della ruota, accrescendone la capacità divoratrice. Due bracci appositi, costruiti con boe galleggianti e reti sommerse simili a quelle usate per la cattura dei granchi, si occupano in ogni momento d’instradare i detriti verso le sue fauci spalancate. Ciò perché naturalmente, la spazzatura non è il più attivo dei nemici dell’umanità, e segue docilmente il suo percorso predeterminato. Così tutto quello che occorreva fare, per dare un primo accenno di risoluzione al principale cruccio cittadino, altro non era che intercettare la nequizia galleggiante, per portarla verso un nuovo stato di congelamento, quel cassone rimovibile a vantaggio della collettività. Ma quante ruote servirebbero, davvero, per ripulire tutto il vasto mondo acquatico che ci circonda? Mille, diecimila? Difficile a dirsi. Però qui, a Baltimora, nel frattempo stanno raccogliendo i fondi per crearne una seconda, presso il quartiere di Canton. Un gesto che la dice lunga sulla fiducia pubblica raccolta in questo anno e mezzo di funzionamento ininterrotto, assieme a tanti impropri scarti di latente civiltà!
Milioni di palle per salvare la città di Los Angeles
La plastica: un materiale dalle applicazioni pressoché infinite. Perché una singola sfera potenzialmente rimbalzante, di per se, è poca cosa. Ma bastano due per diventare un gioco. E tre faranno un sistema. Mentre 1.000, 10.000… Possono cambiare il nostro modo di concepire la singola risorsa più importante per l’uomo. L’altro giorno, al cospetto della stampa, della TV, degli assessori della sua giunta e degli ufficiali del LADPW (Los Angeles Department of Water and Power) l’orgoglioso e sorridente sindaco della seconda città più grande degli Stati Uniti, Eric Garcetti, ha rovesciato un sacco di plastica in prossimità di un’irta discesa in cemento. Assieme a lui dozzine di persone, in parte dipendenti dell’azienda che ha ricevuto l’appalto, in parte fortunati invitati all’improbabile evento, hanno fatto la stessa cosa a partire da un punto diverso, causando lo scroscio impressionante di ben 20.000 “shade balls” (palle nere) impegnate nella più gloriosa rotolata della loro vita passata e presente, verso il bacino del Silver Lake Reservoir, ricolmo di 3,010,000 metri cubi d’acqua, almeno in teoria, potabile. L’ultimo carico di un totale vertiginoso, che attualmente si aggira sui 96 milioni di loro simili, gettate come uova di caviale sopra un lago artificiale. Il problema ed il nocciolo della questione, infatti, è proprio che dei test effettuati recentemente nella struttura hanno rivelato nel serbatoio una pericolosa contaminazione di bromato, sostanza lievemente carcinogena per l’uomo. Eppure non si può fare a meno di un tale polmone acquoso, soprattutto al tempo della lunga siccità che ha coinvolto l’intera California, nonché parti dell’Oregon, del Colorado e dello stato di Washington, una situazione che sta ormai da anni condizionando il benessere di decine di milioni di persone. Cosa fare, dunque? Prima di ogni altra cosa, svuotare il serbatoio (temporaneamente) per poi riempirlo gradualmente di nuovo grazie al possente ma sempre più affaticato acquedotto cittadino, con origine dal fiume Owens della Sierra Nevada, costruito all’inizio del secolo scorso dal celebre visionario William Mulholland. E poi proteggere la nuova massa d’acqua in maniera quasi totale, analogamente a quanto era stato fatto nell’estate del 2008 con il vicino e ben più piccolo Ivanohe’s Reservoir. Perché l’indesiderabile bromato è la risultanza accidentale della combinazione fra tre componenti: lo ione bromite, una sostanza chimica che si forma naturalmente nell’acqua proveniente da falde acquifere sotterranee; il cloro, da sempre impiegato per disinfettare l’acqua da bere esposta agli elementi; e la luce del Sole, che scalda ed attiva il miscuglio nel giro di qualche mese. E forse apparirà strano a dirsi, ma fra i tre fattori, l’unico che si potesse rimuovere era proprio quest’ultimo, visto che non era endemico o necessario. Sul come, inizialmente c’erano piani divergenti. Fra tutti prevalse inizialmente un sistema dall’alto grado di sofisticazione, che sarebbe consistito in una diga per tagliare a metà i due serbatoi, fornita di teli per proteggere la nostra acqua dai raggi UV. Con il piccolo problema del costo, che si sarebbe aggirato attorno ai 300 milioni di dollari. Una cifra non esattamente facile da dedicare a un singolo problema, persino per una città da 13 milioni di abitanti come LA. Così, a qualcuno venne l’idea, presa in prestito da certi grandi aeroporti con il problema delle anatre selvatiche vicino alla pista di decollo, di coprire lo specchio d’acqua con un certo numero di quelle che vengono comunemente definite conservation o shade balls, sferette scure dal diametro di 10 centimetri e dal costo approssimativo di 96 cents ciascuna, semi-riempite d’acqua affinché il vento non se le porti via. Ed ora, finalmente, l’opera è completa!