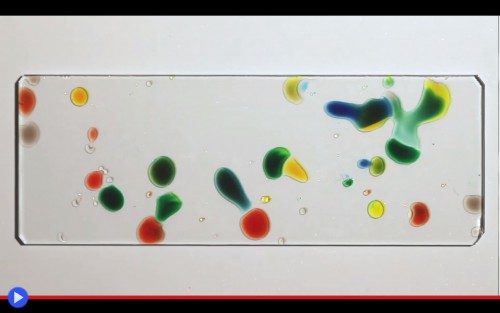Tutti conoscono, o per lo meno hanno sentito parlare, della leggendaria rosa del deserto. Un fiore nascosto sotto la sabbia delle dune, racchiuso in forma dormiente all’interno di un agglomerato di cristalli di gesso, che per innumerevoli anni e secoli può attendere il suo momento. Finché un giorno, per ragioni incomprensibili, la strana pietra si fessura, e da essa sorge uno svettante fusto del colore di una quercia. Che cresce, e cresce verso il cielo, fino a spalancarsi in un tripudio di sfaccettature frastagliate. Ed è a quel punto, dai suoi petali, che sgorga la più preziosa tra le ricchezze dei viaggiatori: copiosa, rinfrescante, chiara e dolce… Certo, lo scienziato non può che restare perplesso. Niente di simile ha ragion d’esistere in alcun ambiente, e la strana pietra , ce lo insegna la geologia, non è in realtà altro che un litotipo formatisi presso una riserva evaporitica nel sottosuolo. Ma l’ingegnere aggiungerebbe: si, una cosa simile possiamo costruirla. Si, una cosa simile l’abbiamo GIÀ costruita. Si chiama Waterseer, e potete finanziarla (nonché prenotarla) qui.
Fondamentalmente, l’avevamo sempre saputo: per assicurare la prosperità dell’intero consorzio umano, senza limiti di geografia o confini, è assolutamente necessario fare affidamento sulla tecnologia. Non è purtroppo possibile, preso atto dell’attuale numero di individui che vivono nel mondo, per non parlare delle prospettiva della loro crescita futura, pensare di accontentarsi delle sole naturali risorse del pianeta Terra. Il cibo non è infinito, il carburante non è infinito. E per quanto concerne l’acqua… Come probabilmente ben saprete, il liquido per eccellenza è una delle sostanze più comuni presso lo sferoide che chiamiamo Casa. Il 70% del mondo ne è ricoperto, mentre il nostro stesso organismo, che si è evoluto a partire da un simile brodo primordiale, ne è composto al 50-60%, fino al 78% nei neonati. Ma volete sapere quanta dell’acqua che vediamo con i nostri occhi è in percentuale adatta al consumo da parte da nostra? In effetti, non più del 2,5%. Ed è per questo che ogni giorno 8.000 persone muoiono di sete, mentre altre 1.000 subiscono le conseguenze di una delle molte malattie a cui si è soggetti tentando di dissetarsi da una fonte inadeguata.
Fino a un tal punto, è forte il nostro istinto di sopravvivenza: bastano poche ore senza bere, oppure un singolo giorno, perché la disperazione possa portarci a ricercare la potabilità dove in realtà, essa non sarebbe mai potuta esistere, a causa dell’inquinamento, dei microbi o della sporcizia. Come altrettanto celebre è l’immagine, più volte messa in evidenza per stimolare le nostre coscienze, delle madri o padri in determinati paesi aridi che devono percorrere, ogni giorno, numerosi chilometri per raggiungere un distante pozzo e assicurare la sopravvivenza della propria famiglia. Il che, in luoghi che risultano il più delle volte disagiati anche dal punto di vista economico e dei servizi, assicura l’impossibilità di svolgere un lavoro edificante, acquisire nuove capacità o semplicemente passare del tempo con i figli. Ed è per far fronte ad una tale spiacevole situazione, che ormai da svariate decadi diverse organizzazioni umanitarie stanno ricercando lo strumento risolutivo, un apparecchio che permetta, in qualche modo, di incrementare la quantità di fluido dissetante disponibile dove gli acquedotti civici non sono mai esistiti, e mai potranno farlo in futuro. Gli approcci sono molteplici: filtrare l’acqua non potabile o depurarla, per renderla tale, permettere di trasportarla in modo più efficiente, ad esempio attraverso dei serbatoi portatili concepiti per rotolare sul terreno, oppure crearla dall’aria stessa, attraverso il processo della deumidificazione. Proprio questo ultimo metodo, sulla carta, potrebbe sembrare il migliore, benché tenda a richiedere dei ponderosi, costosi macchinari, nonché l’ancor più problematica risorsa dell’energia elettrica. O forse sarebbe più corretto dire, che così è stato fino ad oggi.