Come certamente ben sapranno i fan di Dragonball o una qualsiasi altra serie fantastica di arti marziali, uno dei concetti più importanti nella rappresentazione estremo orientali del potere sono le aure luminose, che permeano la figura corporea di tutti coloro che hanno raggiunto una stazione più avanzata sulla strada verso l’illuminazione. Connotazione estetica che nelle statue, nella pittura e perché no, anche nella moderna cultura di massa, gli studiosi d’iconografia amano definire mandorla, per la sua forma piatta in corrispondenza del suolo, ed allungata verso il lato superiore della scena. Il che dimostra, incidentalmente, il modo in cui la frutta secca fornisca la perfetta metafora per molti aspetti di una delle religioni più diffuse d’Asia, come quella particolare circostanza, sorprendentemente desiderabile, di vivere la sbucciatura di una noce… Nel Museo Nazionale di Kyoto, su gentile concessione del tempio di Saion-ji, è custodita da oltre un secolo una statua lignea particolarmente affascinante risalente addirittura all’epoca Heian (794 – 1185) e che dovrebbe raffigurare, almeno secondo le fonti filologiche a disposizione, la figura semi-mitica del monaco Baozhi, vissuto durante la vita dell’imperatore cinese Wu dei Liang (regno: 502–549) e che fu un discepolo diretto del sommo patriarca Zen, Bodhidarma. Costui, raffigurato sopra un piedistallo a forma di fiore di loto, in abiti da pellegrino e con in mano una bottiglia, presenta una condizione somatica particolarmente inusuale: la sua faccia è infatti spaccata longitudinalmente, con le due metà che si separano ed al centro un nuovo volto, identico, che spinge per conquistarsi uno spazio fra le orecchie e al centro della testa. E chi sarebbe mai, costui? Secondo alcuni, nient’altro che il bodhisattva Kannon (anche detto/a Avalokiteśvara, Guānyīn) personificazione della misericordia, a volte donna, a volte uomo, con la caratteristica di innumerevoli volti e braccia, usati per assistere chi soffre sulla Terra. Secondo altri, un diverso aspetto del monaco stesso, la sua essenza liberata finalmente dalle catene e dai pesanti bisogni della vita terrena. Ed è certamente verso questa seconda ipotesi, che tende la neo-rappresentazione della stessa cosa messa in scena dal quotato artista giapponese Takashi Murakami in occasione dell’inaugurazione della sua nuova mostra “I 500 Arhat” presso il museo Mori nel quartiere Roppongi di Tokyo, che rimarrà aperta al pubblico fino al 6 marzo del 2016, dopo un’assenza ormai protratta per un tempo superiore ai 14 anni. Prima di tornare, come un fulmine variopinto, accompagnato da una vasta serie di opere tra cui quella che dà il nome all’evento, ovvero un titanico dipinto lungo circa 100 metri, che rappresenta nelle sue quattro “regioni” dedicate alle direzioni cardinali le innumerevoli figure dei titolari santi del buddhismo, coloro che per primi o con effetto duraturo scelsero di seguire gli insegnamenti della figura storica di Śākyamuni. Un soggetto dalle forti implicazioni filosofiche, a cui l’autore mise mano per la prima volta nel 2012, assieme ai giovani creativi del suo collettivo Kaikai Kiki, incontrando significativi ostacoli ad un rapido completamente. Eppure, non occorre un’approfondita analisi critica o di contesto, per comprendere come molti degli aspetti estetici che scaturiscono dall’incontro tra l’artista e la religione abbiano un intento di rottura col passato, quando non addirittura, pienamente satirico ed irriverente. Molte delle figure, sembrano orchi, mostri, diavoli cornuti!
Particolarmente evocativa, a tale proposito, potrebbe anche dirsi la maschera di sicuro impatto indossata dal principale figurante reclutato in occasione dell’apertura della mostra (potrebbe anche essere stato l’artista stesso, chi può dirlo) con il volto di Murakami colto nell’attimo in cui sta subendo la stessa trasformazione di Baozhi, con tanto di occhi mobili e il rosso sangue visibile sotto la finta “pelle”. La pagina Facebook ufficiale ne mostra l’attenta preparazione, attraverso l’impiego di materiali plastici e componenti mobili meccanizzate. Di certo, l’antico autore religioso della statua del tempio di Saion-ji sarebbe rimasto assai colpito dalla parte tecnica di un simile progetto. “Ma c’era proprio bisogno…” Avrebbe presto aggiunto, perplesso dall’intramontabile preponderanza dell’ego: “…Di usare un volto uguale a quello dell’autore?”

Il dipinto degli Arhat, rimasto incompiuto per quasi un anno, fu finalmente portato a termine nel 2012, con l’obiettivo dichiarato di dar sfogo ai sentimenti di Murakami nei duri mesi immediatamente successivi al grande terremoto del Tohoku, durante il quale una delle prime nazioni a portare soccorso, egli ci racconta, fu alquanto inaspettatamente il distante stato arabo del Qatar. Così l’artista decise, senza un attimo di esitazione, di organizzare la sua prima mostra in Medio Oriente presso il Museo dell’Arte Islamica di Doha, e di lasciare addirittura, ad esposizione completata, il suo capolavoro in dono al popolo ed al governo locale. Proprio per questo il temporaneo ritorno del dipinto in Giappone, per la prima volta mostrato ufficialmente in patria per diretta intercessione di uno artista che aveva sempre cercato i suoi palcoscenici all’estero e su scala internazionale, assume un significato mediatico decisamente significativo. La mostra, ad ogni modo, è arricchita da una vasta selezione di altre opere, tra cui l’autoritratto fotografico “Reborn” dal quale è stata tratta l’idea per la maschera di Baozhi, più l’ampia serie di raffigurazioni dell’artista in stile manga, intitolata Enso e che lo pone sullo sfondo dei più diversi recessi universali e ultramondani. In determinati casi, a tale figurina si sostituisce Mr Dob, il gatto robotico che costituisce ormai da anni l’avatar giocattoloso dell’artista. Non manca poi una corposa rappresentanza della sua produzione scultorea, con una sala dominata dall’imponente Grido di Nascita dell’Universo, un gruppo statuario metallico dell’altezza approssimativa di tre metri arricchito da motivi fiammeggianti e con figure a forma di teschio nel suo centro nebuloso, che riportano in mente il tema dell’esplosione atomica.

Si potrebbe essere tentati, nell’analizzare questo artista dalla formazione rigorosamente classica (Murakami nasce nel 1962 e ottiene la sua laurea con specializzazione sul Nihonga, la pittura tradizionale giapponese) di fondare la sua poetica sulla capacità tipicamente giapponese di “unire l’antico al moderno” quando in effetti, lui va fa un importante passo successivo. Autodefinitosi dal 2001 il fondatore del movimento artistico Superflat, un modo specifico di vedere l’arte contemporanea che nel tempo è diventato anche un redditizio brand commerciale, egli nega infatti l’esistenza stessa di una distinzione tra arte alta e cultura Pop, viste come due regioni della stessa branca dello scibile, senza nessun tipo di confine apparente. Una visione che gli valse presto numerosi apprezzamenti dall’estero, al punto da guadagnarsi in determinati ambienti l’invidiabile noméa di “nuovo Andy Warhol” ma che fu sempre mal vista negli ambienti accademici del suo paese dove, per citare la rinomata rivista Juxtapoz, c’è Sempre un Tempo e un Luogo, per Tutto. Non a caso lo stesso Murakami lamentava, proprio in quell’intervista, il modo in cui esista una sorta di naturale diffidenza in Giappone, per cui più un artista, di qualsiasi tipo, ottiene successo all’estero, maggiormente deve impegnarsi per sfondare tra un pubblico di compatrioti. Non che questo l’abbia mai condizionato, più di tanto!

Ha avuto una forte risonanza mediatica, negli ultimi giorni, la recente iniziativa del celebre produttore di borse Louis Vuitton, che ha scelto come sua nuova testimonial internazionale niente meno che Lightning dei videogiochi Final Fantasy, al secolo (fantastico) Claire Farron, un’eroina digitale fortemente voluta dall’autore ludico Tetsuya Nomura come sua prefigurazione della “donna ideale”, atletica, magrissima e dai capelli naturalmente vivacizzati da un tenue color rosa. Quello che tuttavia molti non sapevano, o non si sono preoccupati di ricordare, è che questa inaspettato passo verso il contemporaneo d’Oriente non è il primo compiuto dal prestigioso marchio francese, né il maggiormente significativo. Risale infatti addirittura al 2002 la collaborazione tra lo stilista americano Marc Jacobs e Takashi Murakami per la realizzazione di un progetto multimediale, naturalmente finalizzato alla pubblicizzazione di una linea di accessori di moda particolarmente insolita nel suo incorporare, tra le caratteristiche LV ripetute ad infinitum dall’azienda, alcuni piccoli personaggi ed occhi colorati. Quelli, per l’appunto, di uno strano personaggio simile ad un orso di peluche, protagonista di due bravi cartoni animati, che inaspettatamente divorava una bambina per trasportarla temporaneamente in uno strano mondo di fantasia. Il mondo della creazione registica, del resto, ha affascinato notevolmente il Murakami degli ultimi anni, portandolo tra le altre cose, assieme alla sua squadra del Kaikai Kiki, a realizzare un film per bambini sull’impostazione di Pokèmon e/o Yokai Watch, intitolato Jellyfish Eyes, uscito nel 2013 con un moderato successo locale, ma purtroppo la bocciatura dei critici internazionali. Una strana inversione della sua tendenza come artista.
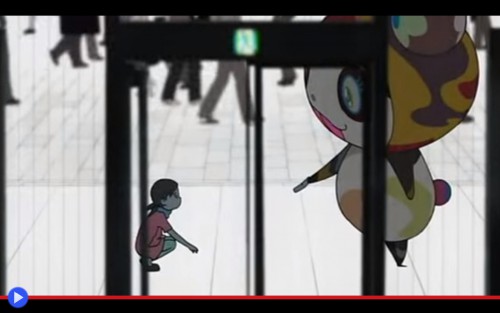
Un creativo aperto ad ogni potenziale via d’accesso alla divulgazione, dunque, che oggi offre il suo nome come firma del lavoro, ed occasione formativa, per numerosi esponenti della nuova generazione di artisti contemporanei giapponesi. Particolarmente famosa, in particolare, è la serie di mostre dei suoi discepoli intitolate GEISAI ed organizzate negli spazi del centro commerciale di Nakano Broadway a Tokyo, una mecca degli otaku di ogni nazionalità, dove apprezzare l’arte propriamente detta tra negozi di fumetti, videogiochi e mandarake, ovvero tutti i gadget e l’oggettistica di contorno. Ma che fu famoso anche per la sua collaborazione con il rapper americano Kanye West, per il quale realizzò nel 2007 la copertina dell’album Graduation ed il relativo video musicale.
Nel maggio del 2008, Murakami assurse nuovamente alle cronache per la vendita record della sua statua My Lonesome Cowboy, raffigurante un tipico personaggio dei fumetti giapponesi intento a masturbarsi, generando una sorta di lasso cosmico fatto roteare al di sopra della propria testa, rigorosamente ornata dagli irrinunciabili capelli a punta. Una critica d’artista, tutt’altro che velata, alle pervasive implicazioni erotiche di un mercato che ad oggi costituisce, forse anche all’insaputa di molti giapponesi, la principale esportazione culturale di quel paese. Che si dimostrò in grado di aggiudicarsi ben 15,2 milioni di dollari ad un’asta di Sotheby’s! Niente male, davvero…


