Verso l’una di notte del 26 aprile 1986, le barre di carburante radioattivo site nel nucleo del reattore di Chernobyl, in Ucraina, iniziano inspiegabilmente a surriscaldarsi. In quello che venne definito inizialmente un “test di sicurezza” il personale della centrale decide quindi di inviare il comando remoto che le avrebbe fatte ritrarre, portandole a raffreddarsi in un apposito alloggiamento pieno d’acqua. Ma qualcosa, appare subito chiaro, non sta andando per il verso giusto: l’uranio contenuto al loro interno aveva infatti già raggiunto una temperatura sufficiente ad indurre la fissione dell’atomo, e trovandosi così racchiuso, iniziò a trasformare il liquido in cui era immerso in idrogeno ed ossigeno. In un moderno impianto di generazione dell’energia nucleare, naturalmente, ciò non avrebbe costituito un gravissimo problema; sistemi meccanici di apertura e valvole di sfogo sarebbero ben presto intervenuti, lasciando defluire il vapore radioattivo in appositi condotti, senza gravi conseguenze per l’ambiente e le persone circostanti. Ma simili norme costruttive, a quell’epoca, non erano state ancora applicate, ed in effetti lo sarebbero state proprio a seguito di quello che stava per succedere di lì a poco: un disastro totalmente senza precedenti. La massa del fluido refrigerante a quel punto aumenta infatti a dismisura, finché non giunge a premere con forza contro le pareti delle tubazioni e del suo serbatoio. Ad un tratto, la resistenza strutturale di simili strutture viene meno, ma niente affatto gradualmente, bensì con un catastrofico disfacimento esplosivo, mentre tonnellate di grafite vaporizzata, cariche di pericolose radiazioni ionizzanti, vengono diffuse negli strati superiori dell’atmosfera, da dove il vento le trasporterà per mezza Europa. Tuttavia, una parte del contenuto del reattore prende una strada totalmente differente. L’uranio delle barre di controllo infatti, essendo un metallo solido e pesante, inizia piuttosto a fondersi, coinvolgendo nel processo anche il cemento, l’acciaio ed il terreno sottostante. Il tutto forma una colata pseudo-lavica che alla sua temperatura di diverse migliaia di gradi inizia a disgregare il pavimento, colando in modo inesorabile verso i piani interrati della centrale. Quindi il blob, liberatosi dell’energia termica in eccedenza, si solidifica di nuovo in una forma simile a una coda di lumaca. O per usare il termine di paragone più comune, il piede corrugato di un titanico elefante. E quella massa ancora giace, lì. Perché la sua eminenza grigiastra, nei fatti, rappresenta quello che potrebbe definirsi il singolo oggetto artificiale più pericoloso della Terra, con un’emanazione di onde disgregatrici che superava, all’epoca immediatamente successiva all’incidente, 10.000 roentgen l’ora, più che sufficienti ad uccidere sul posto una persona adulta nel giro di 300 secondi. O condannarlo a morte nel giro di un paio di giorni dopo un singolo minuto. Persino quarant’anni dopo, oltrepassare la misura di sicurezza del sarcofago ed avvicinarsi a questo folle monumento, restando in sua presenza per qualche minuto, basterebbe a garantire conseguenze gravi. Eppure, non c’è nulla di maggiormente innocuo, all’apparenza, ed immobile e insignificante, di un simile ammasso di pietra metallifera, abbandonato giù nel buio di quei sotterranei in rovina. Le radiazioni sono state definite, con ottime ragioni, “il killer invisibile” perché non lasciano alcun tipo di effetto nello spettro visibile dall’occhio umano, almeno, non lo fanno in condizioni…Normali.
Nel 1894, il fisico scozzese Charles Thomson Rees Wilson si trovava per lavoro in prossimità della cima del Ben Nevis, la singola montagna più alta della Gran Bretagna. La giornata volgeva al termine, ed il cielo era tutt’altro che sereno, al punto che con lo stagliarsi del massiccio contro il Sole, avvenne un fenomeno piuttosto interessante nonché raro, comunemente definito dello “Spettro di Bracken”. In termini più diretti, l’ombra del Nevis venne proiettata contro quella di una nuvola distante, riproducendo la sua sagoma a mezz’aria: “Che bello!” avremmo detto noi. Ma lui, che era uno scienziato, pensò invece qualcosa sulla linea di: “Ciò dimostra chiaramente come sia possibile osservare una cosa inconoscibile, quale la luce dell’astro solare, non direttamente, bensì piuttosto attraverso l’effetto che produce sull’ambiente circostante! Dovrò riprodurre questa progressione in laboratorio…” Wilson era infatti impegnato, in quegli anni, nello studio delle particelle subatomiche, ed in particolare nell’effetto che quest’ultime potevano avere sull’ambiente circostante. Così, di ritorno dalla sua escursione, costruì il prototipo che gli sarebbe valso il premio Nobel, e che qui vediamo riprodotto ed impiegato in video, con un approccio costruttivo più moderno: la camera a nebbia, o cloud chamber. Un dispositivo che consente, introducendo al suo interno una fonte minerale o un gas in corso di decadimento, di visualizzare finalmente nel vapore d’alcol la tempesta letterale di proiettili, protoni, neutroni ed elettroni, che costantemente minaccia l’integrità delle nostre preziose cellule, quelle che ci permettono di camminare, parlare ed osservare il mondo.
Ed ecco, quindi, la realtà. Questa emanazione energetica delle sostanze irradianti, che tendiamo a considerare come un campo di forza grossomodo sferico tutto attorno all’oggetto incriminato, in realtà non ha nulla di netto e definito. Ma si compone, piuttosto, di una grande quantità di microparticelle scagliate alla rinfusa, il cui moto è tanto costante, ed impossibile da prevedere, che nei fatti l’astrazione si trasforma in un’imprescindibile necessità. Basta osservare l’effetto avuto da alcune pietre a base d’uranio nel video d’apertura, che s’irradiano a raggiera nella parte illuminata dello spazio deputato, per rendersi conto di come non sarebbe più facile evitarle, di quanto non sia farlo con la pioggia, o per meglio dire, una minuscola grandinata di pietruzze. Talmente piccole da penetrare tra le fibre dei vestiti, dentro i pori della pelle. Finché non colpiscono qualcosa, per restare lì. Nell’osservazione di una camera a nebbia, è possibile prendere atto di due dei tre tipi fondamentali di radiazione: le onde alpha e beta. Nel primo e più infrequente caso, si tratta di aggregazioni formate da un paio di neutroni ed altrettanti protoni, che vista la loro massa relativamente elevata formano delle linee rette, lunghe e spesse. Simili radiazioni non sono generalmente letali sul breve termine, perché non riescono a penetrare la pelle umana. Possono però causare il cancro ai polmoni, se inalate. Mentre ben più diffuse, e pericolose, sono quelle formate dai singoli elettroni scagliati alla rinfusa nelle onde beta, che s’impattano tra loro e poi disegnano parabole vertiginose. Proprio quest’ultime, generalmente, inducono i danni biologici alla base delle malattie da radiazioni. Il terzo tipo di effetto sono i raggi gamma, talmente sottili e rapidi da non lasciare traccia nella camera a nebbia. Un esempio tipico di questi ultimi sono i cosiddetti raggi cosmici, che bersagliano continuamente il nostro pianeta senza gravi conseguenze (finché l’intera razza umana non verrà spazzata via, secondo un’ipotesi relativamente diffusa, dall’emanazione fuori scala di una qualche supernova distante, la gamma ray burst).
In un esperimento teorico piuttosto popolare, si chiede allo studente cosa farebbe se dovesse chiudersi in una stanza con tre fonti radioattive, ciascuna appartenente ad uno dei tre tipi citati. La risposta corretta è mettere la beta il più lontano possibile e tenere in mano la alpha, naturalmente con la bocca ben chiusa. Ma non prima di aver ingoiato il raggio gamma, che partirà dallo stomaco ad una velocità tale, e sarà talmente sottile, da fuoriuscire dal corpo senza arrecare il benché minimo danno. Almeno di essere davvero, molto sfortunati…
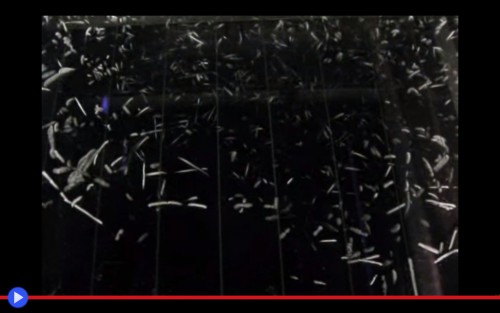
La costituzione di una camera a nebbia non è in realtà eccessivamente complicata. Si tratta semplicemente di uno spazio a tenuta d’aria, come una vetrina sigillata, all’interno del quale è stato introdotto dell’alcol metilico, che come sua prerogativa inizierà ben presto ad evaporare. L’area di osservazione, quindi, verrà bruscamente raffreddata fino a 20-25 gradi sotto zero, tradizionalmente attraverso l’uso dell’anidride carbonica solidificata, ovvero il ghiaccio secco. Ma qualsiasi altro sistema potrebbe funzionare, come dimostrato anche da samol1234567890 (si, era questo il suo nome) il creatore della cloud chamber d’apertura, costruita tramite l’impiego di componentistica da PC ed alcuni elementi di Peltier, diffusi sistemi elettrici di regolamento della temperatura. Ciò che succede, quindi, raffreddando fino a questo punto la camera riempita di vapori, e che questi ultimi tendono a depositarsi verso la parte bassa dello spazio a disposizione, creando nei fatti un’area supersatura, all’interno della quale gli eventi prendono una piega assai particolare. Basterà infatti il minimo sommovimento, come quello causato dalle due classi di microparticelle alpha e beta, per causare delle scie di condensa facilmente visibili ad occhio nudo, dimostrando finalmente l’esistenza fisica delle emissioni radioattive. Un passo avanti niente affatto indifferente, per quell’epoca alle soglie del ‘900. Ed ancora interessante, nonostante ormai esistano approcci di studio ben più avanzati: guardate ad esempio il qui presente video del museo di Berlino, in cui la fonte radioattiva impiegata non è un minerale, ma il gas radon, prodotto dal decadimento del radio. Che a sua volta genera, nel diffondersi dell’aria della camera a nebbia, delle emanazioni di ancor più aleatorio polonio, una sostanza con un’emivita (tempo di dimezzamento della massa) misurabile in decimi di secondi. Così ciascun atomo di questo elemento a sua volta si autodistrugge, proiettandosi in momenti successivi, creando l’immagine ripetuta di una serie di forme a V, ciascuna originante da un vertice comune, oppure una coppia di punti particolarmente vicini nello spazio. Che finiscono per indicare, dunque, l’origine dello spostamento effettuato dall’atomo nel tempo intercorso tra la prima e seconda emanazione, permettendo di vedere, nelle parole di bionerd23: “Lo spostamento di un singolo atomo!” Chi avrebbe mai detto che fosse possibile riuscire a far tanto, con una manciata di materiali facilmente reperibili ed appena un pizzico di manualità costruttiva! Oltre, naturalmente, alla fonte radioattiva da osservare. Forse dopo tutto, un “oltre” niente affatto indifferente.

L’insegnamento principale della camera a nebbia, come quello dei suoi strumenti successori a bolla (bubble chamber) ed a tensione elettrica (spark chamber), è che nulla avviene per gradi netti e definiti, neppure ciò che sembra influenzare il mondo da una dimensione differente, senza tangere minimamente alla materia. Se le radiazioni oltrepassano le pareti, gli abiti e la membrana delle nostre cellule, è soltanto perché sono costituite da particelle tanto piccole e numerose, che riuscire ad osservarle è una missione estremamente difficile. Ma non impossibile, con il giusto recipiente a disposizione. Lo stesso contatore geiger, impiegato comunemente per rivelare la presenza di queste forze estremamente pericolose per l’uomo, trova la sua ragione di funzionamento principale in un tubo riempito di gas a bassa pressione, all’interno del quale due elettrodi generano una corrente a flusso continuo. Per ciascuna volta in cui una particella alpha o beta attraversa questo spazio, il dispositivo emette un ticchettìo. Il dispositivo non rileva nulla, direttamente. Semplicemente ascolta le irregolarità in quello che produce esso stesso, ovvero l’elettricità. Altri approcci sarebbero semplicemente impossibili. Come lo sono per chi osserva l’ombra della montagna scozzese, solenne barriera naturale contro l’implacabile luce del Sole.
- Il video del celebre divulgatore Prof. Martyn Poliakoff dell’Università di Nottingham, in cui si parla del gas radon, dell’esperienza di ricerca degli scienziati scozzesi dell’inizio secolo e viene anche mostrata una camera a nebbia sul finale.
- Suzie Sheehy del Cockcroft Institute ci spiega come costruire una rudimentale versione di questi dispositivi.


