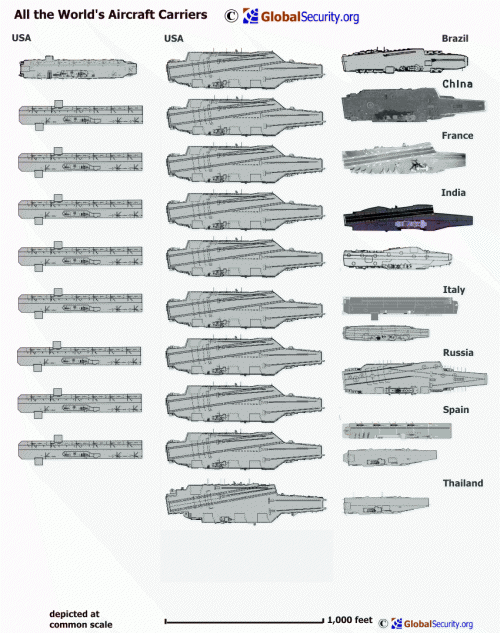Ore 1300, 17 giugno 2015: una sirena che risuona fragorosa tra gli ampi spazi del ponte di volo della nuova USS Gerald R. Ford, la più grande nave militare che abbia mai solcato i mari della Terra, varata alla fine del 2013 ma che non riceverà un suo ruolo attivo almeno fino a Febbraio del prossimo anno. È questo il segnale, tutt’altro che inatteso, per dare il via al momento culmine di una particolare cerimonia, da compiersi sotto la supervisione silenziosa del capitano, il suo entourage, uno stuolo intero di ingegneri. E soprattutto grazie a lei, la donna che questo vascello l’ha bagnato per la prima volta, supervisionando l’uso della classica quanto allegorica bottiglia di champagne. Stiamo parlando, tanto per attribuire un nome alla figura in abiti informali, di Susan Ford, l’unica donna tra i quattro figli del 38° presidente degli Stati Uniti, il cui paterno nome è stato iscritto sullo scafo della solcatrice degli oceani qui presente. E che nave: la prima di una nuova classe, destinata a rimpiazzare nel corso dei prossimi 20 anni le pur ottime, ma ormai attempate 10 consimili della storica USS Nimitz (varo: 1972) prima super-portaerei statunitense con doppio reattore nucleare A4W, fornita quindi di un’autonomia essenzialmente non condizionata dall’esaurirsi del carburante. Ma già scende il silenzio carico di aspettativa sopra questa nuova erede, mentre gli addetti spingono in posizione la vera protagonista dell’evento. Un curioso e ingombrante dispositivo rosso, dalla forma solo vagamente aerodinamica e dotato della telecamera di bordo su una gondola (estrusione di supporto) frontale, il cui peso complessivo, presumibilmente, dovrebbe assomigliare a quello di un qualche aeromobile destinato a far parte dei 75 che trasporterà la nave. Assai probabilmente un qualche modello di F/A-18, ovvero il successore del mai dimenticato F-14, la cui forma angolare, tante volte orgogliosamente messa in mostra al cinema e in tv, aveva condizionato i parametri dell’estetica automobilistica degli interi anni ’70 e ’80. Mentre adesso, nell’epoca del futuribile come ideale collettivo, ci ispiriamo direttamente al mondo della pura fantasia. Due marinai con elmetto protettivo, a questo punto, assicurano dei grossi cavi di metallo al gancio che spunta in mezzo alla rotaia, l’unica parte visibile di un nuovo meccanismo, poi si allontanano e ritornano sull’attenti. L’aria pare quasi fermarsi, mentre l’ospite d’onore alza il braccio sinistro e, in un gesto un po’ rigido, inizia a puntarlo nella direzione del decollo. Ora, naturalmente tutti noi sappiamo che gli aerei della marina in servizio attivo vengono lanciati grazie all’uso di una catapulta. Ma ciò che avviene dopo è un puro esperimento di fisica applicata…
Tra gli aspetti tecnici più problematici delle portaerei a propulsione nucleare, da sempre concepite per restare in servizio molte decadi e venire aggiornate mano a mano, ne permaneva uno dalla significativa inefficienza, eppure troppo oneroso, o complesso da sostituire: il vecchio sistema di lancio del CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery) basato sull’impiego di pistoni a vapore. Un meccanismo potente e affidabile, ma che non aveva mai potuto disporre di alcun feedback nei controlli, agendo sempre nella sua massima potenzialità e conducendo dunque a una significativa usura delle strutture degli aerei. Ciò senza nemmeno considerare la bassa efficienza energetica del dispositivo (ovviamente un problema secondario su un vascello nucleare) stimata attorno a un miserevole 4-6%. Proprio per questo, al momento dell’ordine da 13 miliardi di dollari fatto presso i cantieri di Newport appartenenti alla Huntington Ingalls nel 2005, fu reso subito chiaro che la nuova portaerei avrebbe dovuto ricevere la prima generazione delle nuove catapulte EMALS ad elettromagnetismo (Electromagnetic Aircraft Launch System) in grado non soltanto di generare una spinta potenzialmente maggiore, ma di farlo in modo maggiormente regolare e variabile, riducendo sensibilmente la massima minima degli aeromobili lanciabili con il sistema. Ad esso si abbina un sistema di recupero aeromobili, anch’esso elettromagnetico, dalla maggiore applicabilità e delicatezza. Un aspetto molto significativo, in quest’epoca di droni sempre più leggeri.
Ma eccoci al momento della verità: lei che accentua il suo segnale poi, guardando l’ufficiale a fianco che si abassa e punta in avanti con il fare plateale tipico dei controllori di volo militari, piega le ginocchia e socchiude gli occhi, per meglio osservare il “decollo”. Quindi il blocco di metallo con le ruote che parte, a una velocità considerevole, accelera fino al ciglio del ponte di volo e decolla, sparendo lieve verso l’orizzonte, fra le nubi candide e distanti a largo della California come un agile gabbiano, SPLASH!

Ma l’espediente della catapulta magnetica non è l’unica innovazione della USS Ford, una nave rivoluzionaria sotto molti aspetti. Benché la questione delle dimensioni maggiori sia in effetti grandemente sopravvalutata dai tipici segmenti televisivi dedicati al formidabile vascello, dei miglioramenti nella progettazione e la prassi operativa ne aumentano sensibilmente le funzionalità, rendendo possibile una gestione in contemporanea di fino al 25% di missioni di volo giornaliere in più. Stiamo parlando di ben 160 sortite al giorno. La cosiddetta isola, la torre di controllo da 555 tonnellate con la plancia di comando annessa, è stata infatti posta in posizione più arretrata ed ha dimensioni ridotte, permettendo la designazione di un’area per il riarmo dei velivoli di ritorno sul ponte, che in questa maniera non affollano gli ascensori di discesa negli hangar. Proprio in funzione di ciò, uno di questi ultimi, che erano quattro sulle Nimitz, è stato eliminato, riducendone il numero a tre soltanto, ma ciascuno abbinato ad una situazione di partenza pienamente efficiente. La quarta catapulta delle vecchie navi, ad esempio, non poteva lanciare gli aeromobili a pieno carico, proprio in funzione del poco spazio disponibile, anche si se si decise di includerla perché, come dicevamo, l’efficienza energetica non era mai stata un problema per le navi a propulsione nucleare. Almeno, fino a questi tempi più recenti, in cui il consumo sempre maggiore dei sistemi avanzati di bordo, gradualmente, ha condotto ad una problematica inaspettata: quella dell’output elettrico continuativo e in parallelo verso ciascuna postazione, un’impresa ingegneristica tutt’altro che facile, in grado di condizionare, con l’aumento di peso che ne deriva, la stabilità e l’agilità della nave. Per questo, ogni aspetto della USS Ford è stato progettato sulla base di un nuovo principio di efficienza, mirando dove possibile a ridurre i consumi, nell’ottica dell’aumento futuro della dotazione tecnologica, come è avvenuto per le Nimitz negli ultimi 20-30 anni. Tanto che la nave, al momento attuale, non sta sfruttando che una minima parte del suo potenziale energetico complessivo.
Un altra opera di riduzione è stata compiuta in merito all’equipaggio necessario, ridotto dagli oltre 5000 marinai precedenti ad “appena” 4.660, in funzione di un aumento sensibile degli automatismi di bordo. Sono ad esempio stati installati sensori e dispositivi diagnostici nell’ambito della sala macchine, esonerando gli addetti dal doversi continuamente recare a controllarne il corretto funzionamento. Ciò, incidentalmente, ha aumentato in modo significativo l’autonomia di una nave che può muoversi ad oltre 30 nodi per un tempo virtualmente infinito, e che dunque viene unicamente condizionata sotto questo aspetto dal rifornimento delle provviste e dell’acqua potabile di bordo.

In materia di elettronica, la USS Ford è stata dotata di un radar a doppia fascia AN/SPY- 3 senza parti mobili ma con ben dieci antenne, analogo a quello montato sui nuovi cacciatorpedinieri della classe Zuwalt, in grado di identificare e seguire bersagli a bassa quota anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. I segnali raccolti dal dispositivo, volta per volta, vengono analizzati dalla nuova soluzione tecnica di due supercomputer IBM antiurto off the shelf (ovvero di serie) che li inseriscono automaticamente nella logica dei sistemi bordo secondo “la situazione e i parametri impostati” senza nessun tipo di intervento umano diretto, salvo quelli occasionali di riparazione e manutenzione. Appare dunque evidente, almeno in merito alla questione del rilevamento dei bersagli e la risposta dei sistemi d’arma di bordo, come la nave abbia un cuore oltre che un cervello e possa operare con un certo grado definito di autonomia. Ciò, oltre a ridurre la quantità delle persone assegnate a simili mansioni, ne riduce i potenziali errori, permettendo l’impiego con profitto di una larga serie di sistemi di battaglia e autodifesa. Anche se resta lecito chiedersi chi mai si sognerebbe di attaccare direttamente questa letterale estensione del suolo sovrano degli Stati Uniti, che come le classi Nimitz precedenti sarà presto fornito di un suo codice postale, un giornale e una stazione televisiva di bordo a vantaggio della popolazione di una vera piccola città. Nella guerra del futuro, simili formidabili piattaforme saranno sempre più relegate ad un ruolo di supporto logistico e inespugnabili fortezze, mentre sistemi d’arma telecomandati, fluidi e quasi impossibili da individuare, sostituiranno le vecchie gesta dei pur celebrati aerei e carri armati. In quest’ottica, fra tutti gli investimenti fatti per la difesa dagli Stati Uniti, l’acquisto di queste portaerei è forse quello più utile nel tempo, soprattutto visto che stiamo parlando di un paese supportato dal commercio, notevolmente distante geograficamente dalla maggior parte delle altre super-potenze. Non a caso, il numero complessivo delle portaerei al momento in servizio negli Stati Uniti è più del doppio di quello di tutti gli altri paesi messi assieme, ed è destinato ad essere fatto oggetto di un ulteriore processo di rinnovamento: le successive due navi della classe Gerald R. Ford, la John F. Kennedy e la Enterprise, saranno chiamate a sostituire rispettivamente la Nimitz nel 2018 e la Dwight D. Eisenhower nel 2023.
Per concludere con una nota di sentito patriottismo, dal 2009 anche noi disponiamo di una portaerei all’avanguardia, benché sensibilmente più piccola dei giganti statunitensi: la Cavour C 550, ammiraglia della marina italiana, parte rilevante delle forze d’intervento della NATO. 244 metri per 27.500 tonnellate, andate ad affiancare la precedente Guseppe Garibaldi C 551 del 1983, definita tecnicamente un incrociatore portaeromobili o portaerei leggera. La nave ha ricevuto nel 2011, nel contesto del 150° dell’unita d’Italia, alcuni preziosi cimeli appartenuti al grande statista da cui prende il nome, tra cui un collare con astuccio originale del Supremo Ordine della Santissima Annunziata e un bozzetto del medaglione che decorava il cofano della bandiera di combattimento dell’omonima corazzata della grande guerra. Si potrebbe prendere da qui lo spunto per affermare come almeno dal punto di vista della memoria storica, nella maniera in cui tanto spesso avviene, il primato sia rimasto dalla nostra parte dell’Oceano Atlantico.