Come abbaìno, abbruciacchiato, allofono ed affranto. Chi ha avuto, ha avuto, aha, voluto. Mai dato, solo ricevuto. AAAaah come Arduino d’Ivrea, coraggioso Re d’Italia verso il primo volgere di un’era millenaria. Che rivive casualmente nell’idea, oltremodo interessante, di un’artista d’altre terre, d’altromondo: Kenta Watashima, programmatore. Vuoi scoprire la ragione? Sarà un lungo viaggio. Per prima cosa, traccia il segno della croce sopra un foglio, però inclina il tratto verticale verso destra. Quindi, muovi il tuo pennello in una virgola parecchio generosa, che giunga lietamente fino alle sue estreme conseguenze. Tonda come il sole, vasta quanto il mare. Possa ricordare un’alfa col cimiero, questo simbolo che viene dal Giappone. Ma non è un grecismo, nossignore: così comincia una scrittura fatta dalle foglie. Metti che un popolo guerriero proveniente dalle steppe della grande Asia, avesse costruito dei tumuli sull’arcipelago del regno di Yamato. Pieni di tesori nazionali. E diciamo pure che costoro, stanchi di dover tracciare gli ardui simboli di un alfabeto troppo arcano, per ipotesi, avessero deciso di semplificarli. Quando questo avvenne, non è chiaro: forse intorno al quinto secolo, oppure poco dopo. La risposta è tutta nella datazione di una spada. L’arma del guerriero Wowake, che gli amici usavano chiamare, per far prima: Ōhatsuse-wakatakeru-no-mikoto. Altro che: “d’Ivrea”.
Costui ebbe a ricevere un bellissimo sepolcro presso l’odierna prefettura di Saitama, con il beneplacito del gran signore Waka Takiru, uno dei protagonisti degli annali mitici del Nihon Shoki. Sia chiaro come fossero, tali testi coévi, tutti scritti nella lingua classica importata dalla Cina. Così era l’usanza, nulla più. Finché proprio quel guerriero, giusto sul volgere di un grande giorno, ricevette in dono un’arma in ferro e magnetite meteoritica, la spada che oggi chiamano col nome del suo tumulo: Inaryama. Che fu scavato solamente nel recente ’68, scoprendo, con somma meraviglia, come sulla lama fosse inciso un lungo testo descrittivo. Scritto in lingua puramente giapponese (infine!) Con un metodo che viene detto: man’yōgana. Tale sistema corsivo, basato sempre sui caratteri del continente, li allegeriva però dal significato originario. Dunque, alla dicotomia di un carattere=una parola, a partire da quel giorno, se ne affiancò un’altra; in cui una lettera, da sola, poteva voler richiamare: una sillaba soltanto. Ah! Ah!
E che suono! Il man’yōgana, come per l’appunto dicevamo, deve la sua statura letteraria alla riuscita dalle…Foglie. Ovvero quelle del Man’yōshū, la raccolta antologica che seppe contenerne, metaforicamente, diciamo diecimila. Erano in realtà poesie, compilate, secondo l’ipotesi più accreditata, da Ōtomo no Yakamochi (718-785) statista, scrittore, immortale.
Passati ormai due secoli o giu di lì, dall’epoca di Wowake e della sua spada incisa, la scrittura fonetica aveva acquisito i meriti di un verissimo strumento letterario. E benché i kanji provenienti dalla Cina, come del resto avviene ancora oggi, avessero mantenuto un ruolo di primissimo piano, certi generi finirono per legarsi alla nuova grafia, in cui il suono, non il significato, passava in primo piano. Tra questa la poesia waka (schema di 5-7-5-7 e 7 sillabe) soprattutto per dare origine a dei graditi doppi sensi metaforici, e poi i romanzi, per una ragione alquanto differente: perché li scrivevano le donne.
Nel corso dell’epoca Nara (710 – 784) e ancor più in quella Heian (784 – 1185) l’usanza giapponese voleva infatti che soltanto gli uomini studiassero i caratteri cinesi. Nonostante questo, le donne della classe ricca erano estremamente colte e amavano narrare della vita. Basti, per dimostrarlo, citare l’esempio più famoso: la storia di Genji, lo splendente principe dei Minamoto.
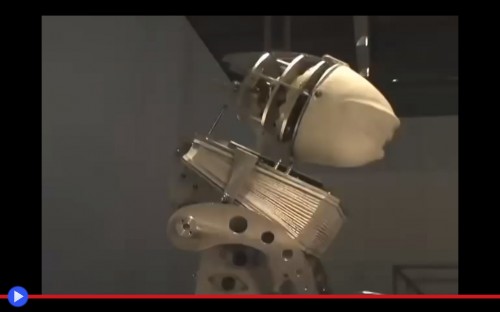
Il Genji Monogatari, forse la singola opera letteraria più influente del Giappone, venne scritto intorno all’XI secolo dalla dama di corte Murasaki Shikibu. Ed è rilevante, in questo caso, perché venne scritto non nell’alfabeto man’yōgana, ma nella sua evoluzione successiva, quella per inciso ancora in uso, che comincia con la croce e con la virgola di Arduino: la [A] Creata dal programmatore d’oggi, Kenta Watashima. Prima lettera dell’hiragana, scrittura del futuro.
Il significato dei suoni linguistici nell’arte giapponese è molto rilevante. Va considerato, tenendo ben presente le vicende di cui sopra, come la cultura antica di quell’arcipelago si sia evoluta per il tramite di un sistema di ideogrammi, in cui il suono derivava solo dal significato. Non dalla scrittura. Il semplice concetto di aprire la bocca, far arretrare la lingua e lasciar vibrare l’epiglottide, a quell’epoca, non veniva razionalizzato. Era un gioco, come un grido. Può essere che una singola vocale sia latrice di significato, in tali condizioni? Giudicate voi, guardando l’opera in oggetto a questo articolo. Ecco, ci siamo.
Veniamo dunque a un altro Re, di una penisola lontana, no vicina, anzi, vicinissima: la nostra. Arduino, che fece la guerra in parallelo ai vescovi di Roma e al Sacro Imperatore, giusto verso l’epoca di Murasaki, scelse di andarsene in pensione. E si ritirò nell’abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, a 40 Km dalla patria Ivrea. Restò comunque caro ai suoi concittadini. Tanto che, oggi, nella città piemontese c’è un bar che porta il suo nome, guarda caso molto frequentato dagli studenti d’informatica dell’Interaction Design Institute.
Gli inventori di una scheda di prototipazione assai particolare, che costituisce uno standard internazionale dei progetti informatici creativi. Controller di suoni, luci e perché no, voci.

Tale minuta attrezzatura, nascosta dentro un guscio alfabetico di lattice, costituisce il cuore della lettera parlante di Kenta Watashima. Che si pone l’obiettivo di dimostrare quanti siano i significati esprimibili per il tramite di una singola vocalizzazione. Entusiasmo, eccitazione, malinconia… Tutto fuoriesce dall’oggetto posto su quel tavolo, in risposta ai gesti dei visitatori. Qualcuno l’accarezza come fosse un cagnolino, altri la percuotono, la punzecchiano con intenzione. Si finisce per provare pure un certo grado d’empatia.
Questa scultura, se così può venire definita, non è che l’ultima rappresentante di una particolare classe di creazioni giapponesi, dette chindōgu, ovvero “strumenti inusuali”. Ce ne sono di ogni tipo, più meno funzionali alle diverse situazioni della vita. Un altro maestro nel crearli è Novmichi Tosa, artista rinomato in modo particolare per l’Otamatone, un giocattolo musicale che produce frequenze simili ad un theremin. Il quale suona un po’ allo stesso modo della nostra [A], a ben pensarci. La vicenda di costui, in un certo senso, dimostra come la creatività artistica possa trasformarsi in una forma di sostentamento, soprattutto grazie a considerazioni di natura commerciale, nonché pubblicitaria. Otamatone, ad oggi, viene venduto nei negozi di metà del mondo, generando considerevoli profitti.
Chissà che anche Kenta Watashima un giorno, abbandonando il suo mestiere principale di programmatore, non scelga di percorrere la strada dell’artista costruttore di gingilli. Ah, magari!


